1990-1999: mille e non più mille?

Riflessioni apocalittiche e poco integrate ricordando un decennio che non era poi così male, dai.
Di Mariella Dal Farra
Pubblichiamo un contributo apparso in Ticino7, questa settimana allegato del venerdì (causa festività) a laRegione.
Siamo a metà del 2020, anno bisestile segnato da una pandemia che non è certo “un raffreddore” (come qualcuno scriveva), con ricadute economiche che si stima saranno anche peggiori di quelle legate alla crisi dei subprime del 2008. Sullo sfondo di questa tragedia, un problemuccio che a occhio e croce qualcosa potrebbe averci a che fare: la spoliazione indiscriminata delle risorse naturali e la devastazione dell’ambiente. Con funeste conseguenze al seguito: riscaldamento globale e migrazioni di massa. Diciamo che ce n’è abbastanza per farsi venire un po’ di nostalgia: la Sehnsucht per quei “tempi migliori” che, visti in prospettiva, ci sembrano circonfusi di luce e di speranza e non solo perché eravamo (un po’ più) giovani, ma anche perché la decade a cui il pensiero si volge ci appare, soprattutto in questo momento, come l’ultimo soprassalto di (auto)coscienza prima dell’inizio della fine. Parliamo di quegli anni Novanta che, con buona pace dei millennials, sono stati fra i più originali, intensi e divertenti di sempre.
Qualche nome, per capirci
Eh sì, gli anni Novanta, quando i ragazzi erano sexy senza essere machi (Keanu Reeves, Kurt Cobain, Beck… Edward Mani di Forbice) e le ragazze non erano programmaticamente sexy perché avevano cose più eccitanti da fare, tipo produrre ottima musica (P.J. Harvey, Cat Power, Elastica) o girare ottimi film (Katherine Bigelow: Point Break e Strange Days). Ecco, diciamo che, in generale, la gente faceva delle cose, o almeno ci provava, invece di limitarsi a essere una faccia, per quanto carina. E non perché si fosse tutti dei geni, ma semplicemente in virtù del fatto che c’era più spazio a disposizione: spazio libero, s’intende, gratuito, fruibile, non a pagamento. Sembra un dettaglio ma comporta tutta la differenza del mondo. È praticamente una legge fisica: ricava uno spazio e la gente lo riempie… di pensieri, idee, musica, arte e opere d’ingegno. Mica tutte buone, certo, ma qualcosa d’interessante nel mucchio si trova sempre. Per chi era giovane nei Novanta, l’universo non era in espansione, com’è stato per i baby-boomers (rif. Offlaga Disco Pax), ma un certo margine sussisteva ancora. In primo luogo, c’era molto più tempo: le giornate non erano rigidamente scandite da impegni extrascolastici supervisionati da adulti; i genitori lavoravano e i ragazzi venivano spensieratamente abbandonati a loro stessi; ci si annoiava un sacco ma era un ozio che ti spingeva a stare con gli amici, non fosse altro che per non annoiarsi da soli. L’auto-organizzazione era un’esigenza che essenzialmente scaturiva dalla necessità di non morire di noia, e da questa all’autogestione, si sa, il passo è breve.

Spazi da occupare, prima e dopo la rete
Ed è così che negli anni ’90 hanno iniziato a proliferare i centri sociali: di solito, edifici industriali dismessi che cadevano a pezzi e che qualcuno decideva di occupare abusivamente per farci ‘qualcosa’. Per esempio abitarci, organizzare concerti o spettacoli teatrali, fare corsi, proporre dibattiti, implementare pratiche di autofinanziamento come i mercatini di abiti usati (oggi, vintage) e quelli di oggettistica cyberpunk. Un retaggio che in una città come Milano è stato capitalizzato dall’East Market e dal Wunderkit, ma insomma non è la stessa cosa… Soprattutto, nei centri sociali ci si poteva andare anche per non fare niente. Attualmente, a parte poche eccezioni che ancora resistono (vedi Csoa il Molino, a cui Ticino7 ha di recente dedicato un contributo della collega Cristina Pinho), se vai da qualche parte devi “consumare”. Che sia l’aperitivo, la cena o l’evento, la prima regola è pagare; per entrare e per stare, e anche per socializzare. Se sei ricco di famiglia è praticabile, altrimenti resti a casa e fai l’hikikomori, che al netto delle complesse determinanti psicosociali è anche un modo per non gravare sul bilancio familiare. L’unico costo “vivo” è quello della connessione a internet, che è l’altro grande spazio nato libero negli anni Novanta ma tradito nei suoi intenti e ideali fino a trasformarsi in quello che è adesso: un enorme mercato immateriale dove la gente compra, se non con il denaro, attraverso quell’altra moneta di scambio che sono i dati personali.
Eppure, quando, trentuno anni fa (era il 1989) Tim Berners-Lee presentò al mondo il World Wide Web affermò che “il Web sarebbe stato aperto a tutti, in tutto il mondo, libero ed esente da qualunque royalty, per sempre”. Sfortunatamente, come lo stesso Berners-Lee ha denunciato di recente, quella che una volta era una coesistenza felice di innumerevoli siti e blog è ora uno spazio monopolizzato dai grandi aggregatori d’informazione, che peraltro detengono enormi quantità di dati sugli utenti. Considerata la deriva presa da internet negli ultimi anni, i primi e forse unici beneficiari degli originali principi ispiratori sono i giganti commerciali come Google, Facebook, Amazon e Twitter.
Il caldo suono del modem
Ho un ricordo, che per qualche motivo mi pare emblematico, di una delle mie prime esperienze di navigazione in rete: il modem analogico si connetteva attraverso la linea telefonica e c’era questa sequenza di suoni sintetici, come se qualcuno componesse dei numeri su una tastiera, seguito da un fischio intervallato da due toni più bassi, e infine un rumore bianco che aumentava d’intensità (forse è più facile andare a risentirlo… lo trovate su YouTube: “Suono del modem 56k”). Alla ricerca di non so più quale informazione, capitai sulla pagina di una ragazza che descriveva la sua passione per i tacchi alti: raccontava cose tipo la prima volta che aveva indossato delle scarpe con il tacco e come si era sentita, ed esponeva una teoria in base alla quale portare queste calzature aiuta a stare bene perché camminare con i talloni a 8, 10 o 12 centimetri da terra sposta il baricentro del corpo, modifica la postura e per questo ti fa sentire meglio… Non ho idea se quello che scriveva avesse senso, ma una cosa è certa: raccontava di qualcosa che le interessava e lo faceva spontaneamente, senza secondi fini. Ora sarebbe una “influencer”: quella strana tipologia di super consumatore che finge di parlare di ciò che gli interessa per indurre consumatori più piccoli a comprare dei prodotti. E che, se riesce a totalizzare un certo numero di visualizzazioni, viene inoltre sovvenzionato dalle piattaforme su cui – e a vantaggio delle quali – genera traffico. Parlare dei propri interessi è diventato un mestiere a tutti gli effetti: la narrazione asservita al consumo, il famigerato “story-telling”, ha soppiantato spontaneità e passione, che ormai trovano spazio solo nella forma degenere dello “hate speech” e del cyberbullismo.
Dove eravamo rimasti…
Alla fine di quel fatidico decennio, Berners-Lee scriveva che “laddove il disegno di Internet e del web è l’individuazione di un sistema di regole che consente ai computer di lavorare insieme armonicamente, così la nostra ricerca spirituale e sociale è rivolta a un sistema di regole che consenta alle persone di lavorare insieme in armonia” (The World Wide Web and the “Web of Life”, 1998, p. 42). Ma questo sogno di una convivenza più equa, capace di andare oltre le logiche del profitto tanto nel mondo digitale quanto nel suo doppio “analogico” – il No logo teorizzato da Naomi Klein nel 1999 – si è infranto con inaudita violenza all’inizio del nuovo millennio. Sono stati due eventi speculari, diversi in tutto ma accomunati nell’effetto, a distruggere l’ipotesi di una globalizzazione “diversa”: la brutale repressione della manifestazione che ebbe luogo a Genova nel 2001 e, qualche mese dopo, l’attacco al World Trade Center di New York. In entrambi i casi, la possibilità di una convivenza transnazionale non improntata allo sfruttamento è stata letteralmente soffocata nel sangue, sostituita dalla paura e dalla logica (solo apparente) della sopraffazione. Sembra che abbia funzionato: nei successivi vent’anni abbiamo ricusato le pratiche “alternative”, rinunciato all’idea di uno spazio libero e ci siamo rifugiati nell’evasione a pagamento dello shopping online e della tv via cavo, ovvero in forme di gratificazione solipsistica nelle quali “l’altro” è superfluo e dà pure un po’ fastidio.
Tutto bene? Non proprio… Le conseguenze di questa rinuncia ci stanno letteralmente esplodendo in mano, e la pandemia che ci ha investiti non ne è metafora bensì perfetta esemplificazione: sintomo del fallimento di quel modello di sviluppo che negli anni Novanta si stava cercando di mettere in discussione. Sarà un segno dei tempi oppure, più probabilmente, dell’età, ma ho la sensazione che sarebbe opportuno tornare a parlarne, di quello di cui si discuteva in quella decade là.
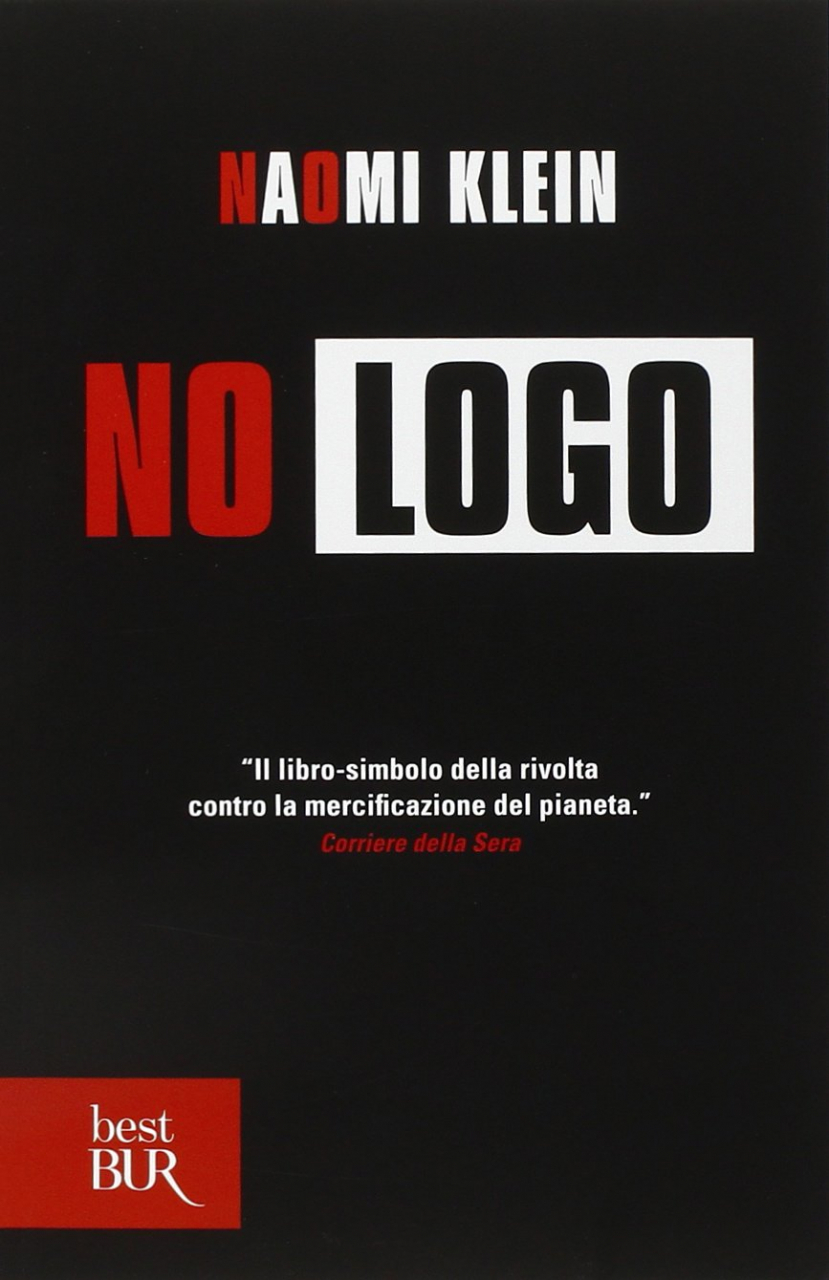
TIME FOR A CHANGE
“Un quarto delle specie animali e vegetali potrebbe estinguersi”
GreenFacts è un progetto no profit fondato nel 2001 con lo scopo di fornire a un pubblico non specializzato dati “strettamente fattuali” di ordine scientifico sulla salute, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile (greenfacts.org). Gli articoli sono presentati in una duplice versione: per punti-chiave e in una forma più estesa, in modo da rendere facilmente fruibili i contenuti che propone. Basandosi sui dati forniti dall’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), un ente intergovernativo indipendente a cui partecipano 94 Stati con lo scopo di monitorare la salute del pianeta, GreenFacts evidenzia come tutti i principali indicatori relativi agli ecosistemi e alla biodiversità stiano subendo un rapido declino. In particolare, a partire dal 1970, 14 delle 18 categorie di risorse naturali prese in considerazione (per esempio, disponibilità di acqua potabile, fattori di regolazione del clima, impollinazione, controllo degli agenti parassitari e altri fattori di riduzione del rischio ambientale) si stanno impoverendo. Circa il 25% delle specie animali e vegetali potrebbe estinguersi, comportando una perdita di biodiversità che porrebbe seriamente a rischio la sicurezza alimentare, indebolendo la capacità di produzione agricola a causa del moltiplicarsi di parassiti e agenti patogeni non più adeguatamente controllati dai naturali fattori di compensazione. Queste alterazioni sono determinate, nell’ordine, da:
1. modifiche nell’uso della terra e del mare;
2. sfruttamento di alcune popolazioni di piante e animali, con particolare riferimento alle coltivazioni e agli allevamenti intensivi, alla caccia e alla pesca non regolamentate;
3. cambiamento climatico;
4. inquinamento;
5. distruzione degli ecosistemi e conseguente migrazione di organismi parassitari da una specie a un’altra… Mmh, vi ricorda niente?







