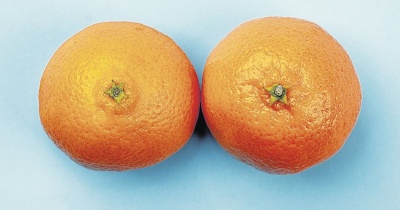A lezione di carcere. Andare ‘dentro’ per capire

Cronaca di una mattinata nelle vecchie Pretoriali di Locarno. Per comprendere e vedere “che effetto che fa”. Ma qui c’è poco da ridere e molto da pensare
Di Lorenzo Erroi
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione
“Ma tanto è come stare in albergo”; “ormai dopo tre giorni son fuori”; “buttate via la chiave”. Molte persone ignorano la vera natura (e la funzione) del carcere. Così come ignorano quanto poco, certe volte, possa bastare per finirci dentro. Un’esperienza didattica aiuta a riflettere sul tema, letteralmente da dentro.
“Giro e mi rigiro e vedo tutto bianco”. “Non si sa se il tempo sta scorrendo o meno”. “Maledetto quel cazzo di rumore che fanno quelle chiavi”. “Bestemmie scritte sui muri. Noia assurda. Voglio uscire”. Sono bastati sessanta minuti di cella per far capire a una classe di ragazzi della Scuola professionale artigianale industriale (Spai) del Centro professionale tecnico di Bellinzona che il carcere non è “un albergo”, come si sente dire ogni tanto da certi tromboni, che la privazione della libertà è uno strazio e tutto sommato non è poi un’ipotesi così remota, neanche per dei ragazzini imberbi: “Meno male che per fortuna non sto più in certi giri, sennò mi trovavo ancora dentro a un buco di merda”, scrive uno di loro. Le frasi vengono dalle note prese durante l’ora ‘al gabbio’, passata in solitudine, con davanti a sé solo un foglio e una penna. L’idea è venuta a Mauro Broggini, un omone con la faccia buona e i modi spicci ma paterni da vecchio bluesman, storico insegnante delle scuole professionali: a metà anni Ottanta è stato tra i primi docenti mediatori in Ticino – quelli che forniscono aiuto e supporto agli studenti che stanno affrontando storie difficili – ed è proprio per questo che si è trovato spesso qui dove stiamo oggi, alle Pretoriali di Locarno, un seminterrato buio, sepolcrale, dove fino a vent’anni fa si poteva rimanere chiusi anche per dei mesi.

© Roberto Marcollo
La fatica di crescere
Oggi per la detenzione reale ci sono la Farera e la Stampa, a Lugano, ma Mauro ha ottenuto l’utilizzo dei vecchi bugigattoli locarnesi per impartire una bella lezione agli allievi del cantone, una lezione che usa l’esperienza per far capire il carcere. Ci si arriva dopo un paio di mezze mattinate in classe – intitolate significativamente ‘La fatica di crescere’ – coordinate in questo caso insieme alla professoressa Laura Mudry. In quel paio d’ore Mauro sfiora Eric Clapton e Ry Cooder, fa ascoltare ‘L’isola che non c’è’ di Edoardo Bennato, ‘Ora’ di Jovanotti, ‘Ti insegnerò a volare’ di Francesco Guccini e Roberto Vecchioni: “Qui si tratta di vivere / non d’arrivare primo / e al diavolo il destino”. Una vignetta di Mordillo fa vedere un omino portato via dalla polizia per avere dipinto casa sua, unica in un quartiere grigio e anonimo. Partendo proprio dalla diversità, dalla discriminazione, da quei traumi grandi o piccoli che possono condurre a errori madornali, Mauro racconta la sua esperienza ‘dentro’: è lui che col progetto InOltre – “‘in’ perché sono dentro, ‘oltre’ perché si preparano al dopo” – ha portato la scuola nelle carceri ticinesi a partire da metà degli anni Duemila, permettendo ai detenuti e alle detenute di imparare l’informatica, l’italiano, la matematica, ma anche materie pratiche quali l’igiene alimentare e la cura della casa. E ai ragazzi ‘fuori’ ricorda: “Il carcere è un’esperienza durissima, sei da solo, ti chiedi cos’hai combinato e cosa ne sarà di te. Vedi gente che fuori ‘ganassava’ e picchiava, pim pum pam, che piange come un vitello davanti alla guardia. Poi è uno stigma che rischi di portarti dietro per tutta la vita, certa gente è capace di metterti un timbro in fronte anche per un furtarello fatto da bocia”. Lo scopo dell’esercizio, insomma, è quello di mettersi nei panni dei detenuti, di provare a intuire almeno remotamente cosa possano patire e che razza di destini attraversino. Non per giustificare tutto – “anche se oggi basta preoccuparsi di certe cose per passare da buonista” – ma per capire. In classe i ragazzi in effetti comprendono, reagiscono, perfino quelli più flemmatici e impacciati partecipano alla discussione. Una studentessa si chiede se “è sbagliato essere diversi” e un suo compagno si preoccupa delle risse in cui ha visto finire anche certi amici, quelli che “fanno a gara a chi ce l’ha più grosso”.

© Roberto Marcollo
Maledette chiavi
Nella penombra delle Pretoriali i compagni di classe vengono separati e rinchiusi uno per uno, ed è tutto un rumore di passi, serrature, sportelli che sbattono. Soprattutto, mentre anch’io mi trovo rinchiuso, c’è il tintinnio delle pesanti chiavi che Mauro porta con sé: un rumore cristallino, acuto, che logora i nervi sempre di più, a ogni minuto che passa. Peraltro quel tempo scorre senza che possiamo misurarlo, dilatandosi proprio mentre tentiamo di riafferrarlo, perché qui non si hanno orologi o smartphone, solo il foglio e la penna per annotare quel che vediamo lì dentro, in quei tre metri per due: lavandino e bugliolo, una panchetta inchiodata a terra e senza schienale, un piccolo banco anch’esso ben assicurato al pavimento, per evitare che qualcuno si faccia del male (anche se “un paio di ragazzi sono riusciti ad ammazzarsi anche qui dentro, impiccandosi con le lenzuola”, ci aveva spiegato Mauro).
Una finestra di vetro opaco, dalla quale non si può vedere proprio nulla, è preclusa dalle sbarre fittissime, bianche come le pareti, che disegnano sul pavimento le sagome del loro intreccio, trecentoventiquattro quadretti per il famoso ‘sole a scacchi’ (uno finisce per contarli quando non sa più cosa fare, e non ci vuole tanto). Il letto è una brandina azzurra con un materasso sottilissimo. Si leggono ancora alcune scritte sui muri: “Sono stato sputtanato”, “Sonia è la mia vita”. Sul lavandino, proprio di fronte al tavolo, uno specchio di sicurezza d’acciaio ossidato riflette solo i contorni sbiaditi del volto. La luce giallastra di due faretti illumina tutto. Afferrarsi la testa tra le mani viene d’istinto, finché a farci sussultare non arriva il fortissimo ‘clac!’ dello sportello da cui un tempo le guardie portavano il rancio (è Mauro che passa a dare un’occhiata per assicurarsi che stiamo bene, e quegli occhi azzurri che sorridono dal corridoio sono già un sollievo perfino per noi, che siamo qua “in gita”). Fuori ci sono i rumori della strada, la vita che va avanti. Chissà cosa dev’essere doverla origliare senza potersi muovere per ventitré ore al giorno – con una sola ora d’aria, aria si fa per dire visto che si passeggiava nel corridoio – per settimane o mesi. D’altronde Mauro ce l’aveva detto: “Dentro il silenzio fa talmente rumore che non si riesce neppure a dormire”.

© Roberto Marcollo
Maree di pensieri
L’esperienza insegna, stavolta è il caso di dirlo: questo gruppetto di 14-15enni – un po’ ciondolanti, segnati dall’acne e dalle paturnie dalle quali siamo passati tutti, con i calzini e le scarpe della Nike tutti uguali e ancora una dose di naturale timidezza verso gli adulti – lo dimostrano dalle pagine che consegnano dopo la ‘reclusione’. Qualcuno ha buttato giù due frasi alla bell’e meglio, interessanti soprattutto per quello che non dicono, nel loro tentativo di distrarsi dalla solitudine: “La cella è lunga 13 scarpe (taglia 40) e lunga 8 scarpe e mezzo”, “ho fatto una pallina di carta, non è tanto ma è qualcosa, dai”. E se “stare qua dentro porta veramente alla pazzia”, c’è chi per resisterle ha scritto un racconto che parla di emigranti, de ‘la rossa e il contadino’, di giubbe blu, Irochesi e “un totem enorme, con dentro scalpellate le loro pagane divinità” cui stanno legati “peccatori, anime ferite e inermi”. Un altro ha disegnato la piantina del carcere, un altro ancora ha scritto una canzone: “La cella è bianca / maree di pensieri / tipo come sta mia mamma”; “L’unico momento in cui sorrido / quando lo sbirro apre la porticina e mi porta il cibo”; “Rimani in un buco aspettando che ti apra il divino”. Una delle poche ragazze osserva che se non altro “la solitudine ti toglie dai giudizi della gente e dagli sguardi” e che “qui si ha il tempo di disinnescare la bomba che si ha dentro”. Che la lezione sia servita ce lo conferma infine una frase semplice, poche parole che ci aspetteremmo di trovare scritte su Tripadvisor, se per le carceri ci fossero le recensioni sul web come per gli hotel e i ristoranti: “Sono stato qui, non ci ritornerei”.

© Roberto Marcollo
LIBERTÀ, SCELTE, RESPONSABILITÀ
“Una cosa in particolare ha colpito molto i ragazzi: l’importanza delle proprie scelte. Il confronto con le storie che Mauro ci ha portato in classe e con l’esperienza del carcere li ha aiutati a capire che sì, ciascuno si trova dentro a una storia di vita che non può dipendere del tutto da lui, però è anche libero di decidere, e certe decisioni hanno delle conseguenze. Ecco: libertà, scelte, responsabilità sono i concetti ‘rimasti’ di più nella classe. E questo è tanto più importante perché, come emerge dai loro scritti, a quell’età è come se si avessero dentro delle bombe pronte a esplodere”. Ad annotare certi cambiamenti è Laura Mudry, che a questi aspiranti polimeccanici e operatori in automazione insegna cultura generale alla Spai di Bellinzona. “È una materia che permette loro, per qualche ora, di restare fuori dagli impegni lavorativi e sociali e di riflettere insieme ai loro coetanei su quella stessa società e su loro stessi come individui. Ripeto da diversi anni il progetto con Mauro, e in questo senso trovo che sia ideale: spinge i ragazzi a soffermarsi sull’importanza di quello che decidono di fare o non fare, ma allo stesso tempo anche di capire la relazione tra il singolo che infrange la legge e la società”.
Al di là dell’evidente lezione circa le conseguenze di infilarsi in certi casini, viene da pensare che dopo l’ora dentro riuscirà un po’ più difficile, per questi adolescenti, uscirsene con invocazioni forcaiole del tipo “buttate via la chiave”. Laura stessa ce lo conferma: “L’attività rende gli studenti meno giudicanti, più attenti al carcerato come individuo e alla necessità di reintegrarlo nella comunità”. Se la cultura generale è “un modo per fargli aprire un po’ gli occhi sul mondo”, la reclusione “li fa riflettere in modo più analitico su una parte di esso che spesso ne viene escluso. Tant’è vero che quando gli faccio leggere un atto d’accusa riguardante giovani poco più grandi di loro, all’inizio propongono pene draconiane; poi, dopo il confronto e la riflessione, la loro proposta di pena si fa molto meno severa e più attenta alla riabilitazione”.
Piccoli ‘buonisti’ crescono? “No, perché non si tratta di giustificare tutto, il discorso torna sempre al concetto di responsabilità e alla necessità di rispettare le regole. Però ci si arriva con maggiore consapevolezza, capendo prima un po’ meglio le conseguenze della condotta personale e gli obiettivi della giustizia. D’altronde, sono la prima a poter dire che l’esperimento funziona: Mauro la prima volta ha ‘messo dentro’ anche me, e anch’io ricordo l’impressione che mi ha lasciato quel tempo sospeso”.

MAURO E LA FIAMMA OSSIDRICA
“Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando”, recita un verso di Jovanotti che Mauro Broggini ci ha fatto ascoltare in classe. Non si direbbe il suo caso, anche perché i sogni per cui ha combattuto una vita – in primis portare la scuola a chi è in difficoltà e a chi è in carcere – li ha anche realizzati con un certo pragmatismo. Oggi in pensione, ma ancora attivo come docente volontario, ha iniziato a frequentare le patrie galere a metà degli anni ’80, quando iniziò la sua esperienza di docente mediatore “e ogni tanto qualche ragazzo, per un motivo o per l’altro, finiva qui dentro”. Storie ovviamente difficili, spesso legate a problemi di droga: “Tutti ci vogliono inscalfibili, ma occorre del coraggio per dire sono triste, non sto bene”. Erano gli anni di quella che i giornali, con pigro fatalismo, chiamavano ‘epidemia’ di eroina. “Era un mondo diverso anche quello della droga, si creava una specie di comunità. Chi è sopravvissuto lo vedo ancora, e forse per me sono quelli i ricordi più belli: quelli di chi qui dentro non c’è più dovuto tornare. Mi fa un po’ lo stesso effetto quando vado a trovare mio figlio a Zurigo e mi siedo su una panchina al Platzspitz di Zurigo, che una volta era un ghetto di tossicodipendenti anche ticinesi,
e ora è un parco bellissimo”.
I brutti ricordi, invece, sono quelli di chi non ha resistito, come S., “che era arrivato qui dopo aver fatto 40mila franchi di danni al Castello insieme a un amico, una notte che erano ‘pieni’. Era riuscito a reinserirsi come operaio comunale, lavorava per ripagare il danno, ma lo bullizzavano. Quando chiese di poter trattenere almeno la tredicesima per fare un regalo di Natale a casa, gli dissero di no. Tornò a drogarsi e alla fine si sparò. Ma ho in mente una sua bella foto, col fisico ancora scolpito e un sacco di cemento in spalla, fatta quando ristrutturammo una cascina a Loco. Quella foto è ancora nel salotto di sua madre, che ne va orgogliosa”.
Con lo svuotamento delle Pretoriali – dettato dalla necessità di rispettare i diritti umani – i detenuti furono spostati nelle più moderne strutture di Lugano: la Stampa, lo Stampino e come prima tappa la Farera, “un porto di mare, dove finisce chiunque venga arrestato tra Airolo e Chiasso, minorenne e maggiorenne”. Lì Mauro ha avviato nel 2006 il progetto InOltre, che col supporto di una squadra di docenti – inviati per alcune ore prima dalla Scuola professionale artigianale industriale (Spai) di Locarno, poi da quella di Trevano – si occupa di portare la scuola in carcere. Scuola che però – e questo vale anche fuori ma soprattutto ‘dentro’ – non è solo libri e lezioni: è un modo per “fare sì che quelle ragazze e ragazzi non si sentano ignorati, che trovino qualcuno vicino, che si preparino a un ‘dopo’”. Appassionato di musica rock e blues, in carcere Mauro ha portato anche, oltre a numerose conferenze, molti concerti “sempre a costo zero e senza alcun disordine. Così come disordini e mancanza di rispetto, generalmente, non si vedono neppure in classe”. Questo nonostante su quei banchi rinchiusi, accanto a chi ha fatto la classica cazzata, ci sia chi dalle carceri entra ed esce. Come il ragazzo che una volta – dopo essere stato arrestato mentre cercava di forzare una cassaforte – rispose alla domanda su cosa avrebbe desiderato per Natale: “Una fiamma ossidrica più potente”.
Insomma, non sempre è facile, non sempre funziona. “C’è chi si è tirato assieme e chi no, e per me quello è sempre il dispiacere più grande”. Mauro poi lo sa, che il carcere “è un modo per isolare chi non sa rispettare le regole e mina la libertà del prossimo”. Ma sa anche cosa significa “sentirsi chiudere dietro alle spalle tutti quei cancelli e quelle porte. Noi insegnanti poi alle cinque del pomeriggio, al più tardi, ce ne andiamo. Loro invece restano lì, 23 ore in cella e una ‘d’aria’, che poi vuol dire ingabbiati sul tetto a fa avant e indré”, spiega con foga davanti agli occhi attenti di tutti. È proprio quello che ci tiene a far capire ai ragazzi, anche a chi resta fuori, come nel caso dell’esperienza che ha già portato alle Pretoriali centinaia di studenti. Sempre con un obiettivo in testa: “Dare un senso allo star dentro”.

© Roberto Marcollo