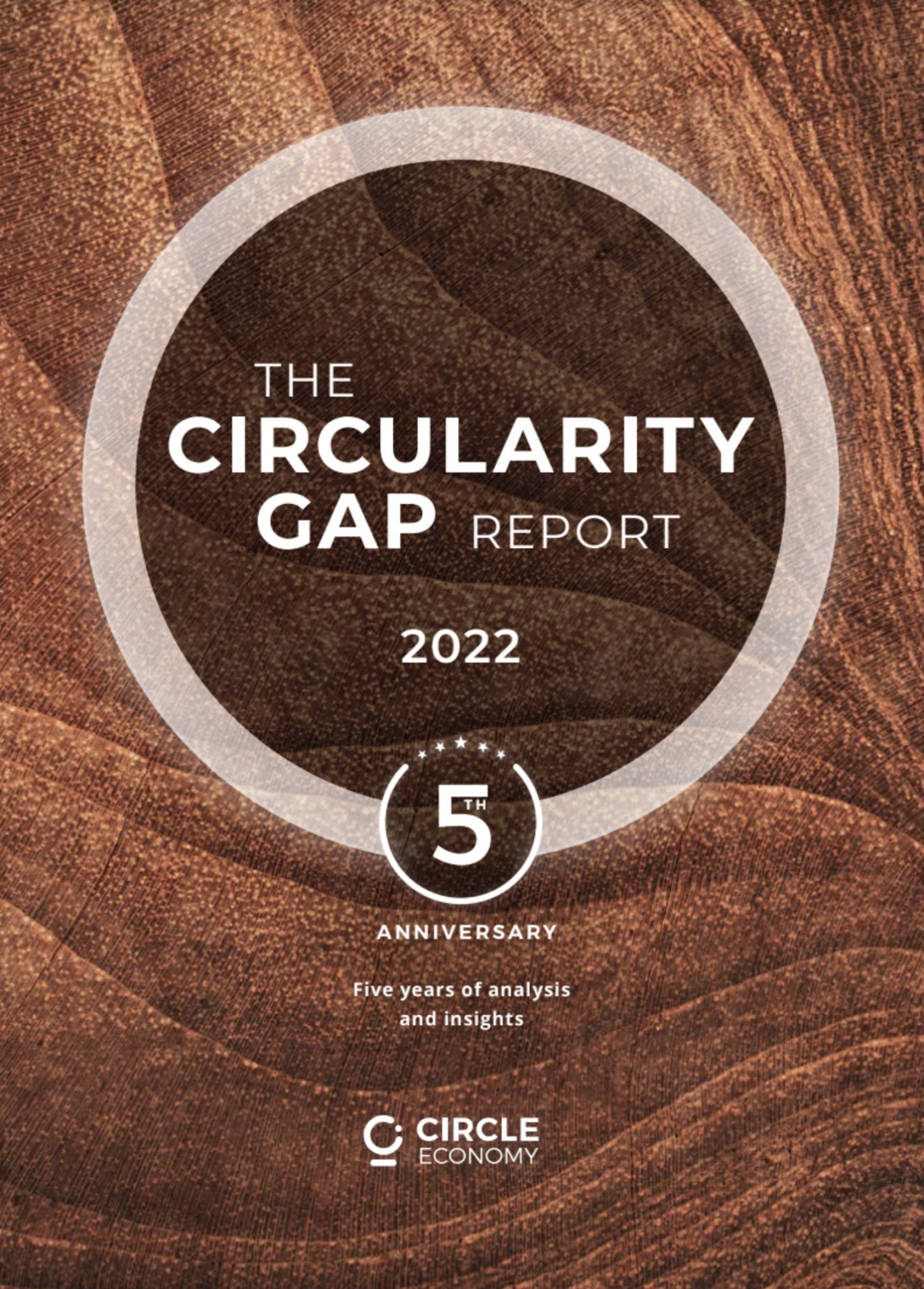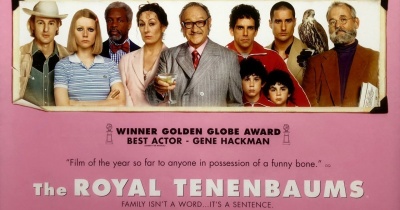La trappola del ‘greenwashing’, il lavaggio verde che confonde

Davvero improvvisamente tutto è diventato ‘green’, amico dell’ambiente e della natura, non inquinante, ecologico o biologico?
Di Marisa Gorza
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione
Oggi sono rare le aziende che non investono in campagne di marketing esaltanti le “genuine” qualità della propria produzione. Sostenibilità è la parola d’ordine del momento, ma su cosa sia effettivamente sostenibile, e su cosa non lo sia, c’è ancora molta confusione. Greenwashing (lavaggio verde), eccolo il termine coniato per descrivere le pratiche volte a migliorare o, addirittura, a creare la reputazione di un’azienda riguardo alle pregnanti questioni ambientali. Una sorta di lavaggio delle coscienze che nel mondo della moda (e non solo) sta sempre più diventando una questione di branding. Magari non sempre con una effettiva responsabilità morale e sociale. Anzi, nei casi peggiori ha solo il discutibile obiettivo di assicurarsi il ritorno economico.
Nuovi dubbi e nuovi interrogativi
In un periodo già difficile per il post-emergenza sanitaria e il barbaro conflitto in atto, sarebbe indispensabile guadagnarsi meritevole fiducia dai consumatori. Purtroppo, molte aziende non si comportano in modo virtuoso. Va detto che il greenwashing non è proprio una novità: il termine è stato usato sin dal 1986 dal noto ambientalista Jay Westerveld, in risposta a una campagna pubblicitaria che mirava a promuovere un’immagine totalmente “verde” di un’azienda legata alla moda che aveva tutt’altra reputazione. Manco a dirlo, la tattica utilizza l’immaginario legato al bucolico e all’incontaminato, e le espressioni più popolari evocanti la protezione del pianeta. Così per le aziende legate alla moda è corsa sfrenata al bollino verde: c’è chi sperimenta nuovi materiali, chi punta alle energie rinnovabili, chi attiva programmi di riciclo… Ma è sufficiente? Ed è tutto veritiero? E così si fanno spazio nuovi dubbi e nuovi interrogativi.
Buone intenzioni, ma…
Meno male che, sulla scia di queste pulsioni, diversi marchi stanno provvedendo a un corretto tracciamento della filiera produttiva, volto a stime attendibili e non solo a slogan acchiappa like. Buone intenzioni a parte, si tratta di obiettivi perseguibili a lungo termine, non facilmente dimostrabili. L’attivista Greta Thunberg ha condannato le aziende della moda definendole un vero e proprio festival del greenwashing. In particolare, è stato puntato il dito contro i marchi del cosiddetto fast fashion, anche se spesso propongono collezioni che vantano un certo grado di sostenibilità. Ma si possono definire sostenibili i capi (magari in tessuti riciclati ad hoc), se i lavoratori della filiera non sono adeguatamente tutelati? O se, per commerciarli, viene richiesto un massiccio uso di mezzi di trasporto molto inquinanti?
In altri tempi, il mai dimenticato Elio Fiorucci, sosteneva che un capo era da considerarsi “etico” da indossare solo se il suo iter produttivo non aveva dato adito ad alcuna sofferenza. Come dovremmo giudicare dunque il cotone, una naturalissima fibra di cotone che in passato (e probabilmente ancora oggi) ha causato non poco dolore, sofferenza e morte nelle piantagioni? Inoltre, i suoi preziosi arbusti richiedono l’uso intensivo di pesticidi e un altissimo apporto e impatto idrico… Le fibre sintetiche sono in effetti meno esigenti dal punto di vista idrico, ma comportano altri rischi riguardanti l’inquinamento ambientale. Un vero ginepraio, insomma.
Un fenomeno di moda
Intanto le operazioni legate alla sostenibilità e i loro risultati “a lungo termine” sono diventati dei veri fenomeni alla moda. E, come tali, inevitabilmente capitalizzati (ma a breve termine). Tra questi, inutile negarlo, si inserisce pure il nostro greenwashing. E così da un lato la moda veloce prospera sul costante ciclo dell’”usa e getta”, mentre la sostenibilità lotta per abbattere proprio tali sistemi: un cagnolino che rincorre la sua coda. Ma la moda – come tutte le attività commerciali – è piena di contraddizioni e incongruenze. Per capirci qualcosa ci siamo rivolti alla signora Micol Costi, operatrice del tessile che ci spiega il punto di vista di chi opera nel settore.

L’importanza dell’etichetta
“L’iter produttivo di un prodotto tessile o non, per ridurre l’impatto ambientale deve sviluppare adeguatamente quattro importanti punti, che vanno dalla composizione del materiale al processo produttivo, dal ciclo di vita utile al fine vita (ovvero cosa si può ancora realizzare alla fine del suo percorso)”, afferma la signora Costi. Ma non sempre tutto ciò viene rispettato:
“Anzi, con la tattica del lavaggio verde a volte si cerca di attribuire un certo valore di sostenibilità al proprio marchio, anche se potrebbe essere ben lontano dal possederlo. Secondo il Circularity Gap Report 2022, stilato da Circle Economy, soltanto l’8,6% dei materiali viene reinserito nell’economia. Quindi il restante 94,4% dell’economia globale – tessile incluso – agisce sempre secondo l’economia lineare del ‘produci-usa-getta’. Ad ogni modo, se da una parte c’è chi trae in inganno, dall’altra c’è pure chi opera, per esempio, nel rispetto delle credenziali GOTS (Global Organic Textile Standard)”.
Ma come si deve orientare il consumatore finale per scegliere marchi la cui sostenibilità è attendibile?
“Può, per esempio, controllare le informazioni riguardanti il prodotto esposte sull’etichetta del capo o del prodotto. Dati afferenti le certificazioni e pure le dichiarazioni spontanee da parte dell’azienda, come il bilancio annuale di sostenibilità. Molte maison lo redigono e lo pubblicano”.
E l’etichetta contenente tutti questi dati è obbligatoria?
“Purtroppo no, o almeno non è ancora prevista dalla legislazione. Tuttavia, vi sono aziende sempre più attente all’aspetto sociale della sostenibilità che cercano di migliorare le condizioni dei lavoratori della filiera. Non ultimo l’uso di un’energia più pulita, come quella solare. Tutto questo fa ben sperare…”.
Sì, speriamo bene, soprattutto in nome della chiarezza e del rispetto del consumatore finale.