MMA o la metafora della guerra
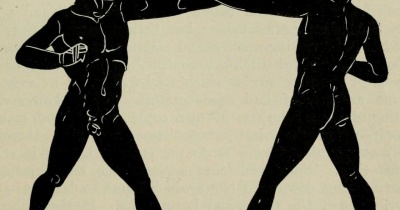
Gli atleti delle Mixed Martial Arts sono spesso antipatici, forzatamente sopra le righe, in cerca di attenzione. E la Svizzera è ben rappresentata
Di Daniele Manusia
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione
Il loro bisogno di visibilità va al di là della capacità d’infliggere dolore e danni fisici ai propri avversari. Spesso hanno tatuaggi brutti – i peggiori sono quelli con il proprio cognome, o il proprio soprannome, scritto in caratteri tridimensionali sul petto oppure sulla schiena – e una comunicazione tossica, ridicola, disperata. Farebbero di tutto per diventare un personaggio della cultura popolare, anche per la ragione sbagliata. Alcuni cercano scientemente di rappresentare il peggio della società, nel tempo libero imparano a sparare con armi da guerra, picchiano le proprie compagne o, peggio, dicono di sognare di uccidere il proprio avversario, che l’unica ragione per cui combattono è perché altrimenti, forse, ucciderebbero qualcuno sul serio.
Le MMA sono uno sport violento, brutale, che talvolta ti costringe a distogliere lo sguardo dallo schermo, e piacciono a persone ciniche, senza empatia, gente che nella maggioranza dei casi vuole vedere il sangue, vuole vedere un uomo (o una donna) sopraffarne un altro (o un’altra) perché quella è la loro idea di vita, di giustizia. Sono “una metafora” della guerra, come ha scritto Alessandro Dal Lago in Sangue nell’ottagono. Antropologia delle arti marziali miste (Il Mulino), ma anche “uno specchio” della cultura globale, in cui la guerra è sempre. Sono uno sport capitalista, che sfrutta i propri lavoratori, sacrificando i loro colpi sull’altare del nostro intrattenimento. Servono a dare sfogo alla “scimmia pazza che adora uccidere” che, secondo Jonathan Gotschall (Il Professore sul ring, Bollati Boringhieri), è dentro ognuno di noi, perché “non siamo nemmeno lontanamente così buoni o civilizzati come amiamo pensare”.
Ok, ma allora perché (quasi) ogni fine settimana mi sveglio in mezzo alla notte senza neanche puntare la sveglia, scendo dal letto senza fare rumore e striscio fino al divano per vederli prendersi a pugni nell’oscurità e nel silenzio del mio salotto? Cosa aggiunge alla mia vita questa mia passione, recente, arrivata in età matura, quando la rabbia giovanile è ormai svanita e i primi allenamenti di pugilato sono un ricordo lontano come quelli delle discoteche pomeridiane?
È una domanda che mi faccio ogni tanto e a cui non trovo una risposta convincente. Anzitutto posso dire, a mia difesa, che non tutti i fighter sono come quelli che ho descritto sopra. Prendiamo Francis Ngannou, per esempio. È il campione dei pesi massimi della Ultimate Fighting Championship, la principale promotion che organizza incontri di MMA in giro per il mondo e che solo nell’ultimo quadrimestre ha avuto un guadagno netto di 288 milioni di euro. È spaventosamente grosso e fuori dall’ottagono si muove con la lentezza tipica dei grandi felini, o dei mostri che emergono dal mare nei film giapponesi. Le teste dei suoi avversari, ex campioni di tutto rispetto pietrificati dalla paura, si muovono come quelle dei manichini del crash-test quando entrano in contatto con i suoi pugni. Con i guantini da MMA, più piccoli e leggeri rispetto alla boxe – e che quindi proteggono meno chi subisce il colpo – Ngannou è una fatina di centoventi chili capace di far addormentare i propri avversari al primo tocco della sua bacchetta magica. E senza neanche bisogno di colpire in modo pulito.

L’arroganza punita. Una rappresentazione dello scontro tra Darete – personaggio mitologico che compare nelle opere di Omero e Virgilio – e il più anziano Entello, già allievo del mitico Erix. Darete avrà la peggio, “vomitando denti misti a sangue”, scrive Virgilio nell’‘Eneide’ (primo secolo a.C.).
Dalla miseria al ring (inseguendo Tyson)
Ma Francis Ngannou è anche un ragazzo educato, sempre rispettoso fuori dall’ottagono. Persino mentre porta avanti un braccio di ferro con il presidente dell’UFC, Dana White – trumpiano convinto, dispotico, che non si fa problemi a chiamare i giornalisti “idioti” – per avere condizioni contrattuali migliori (i fighter sono considerati dei fornitori di servizi, non hanno assicurazione sanitaria, sono pagati solo quando combattono e tra un incontro e l’altro non possono fare praticamente nient’altro, così quando finiscono i soldi sono praticamente costretti ad accettare le condizioni dell’organizzazione), si esprime in toni pacati, con una voce dolce e un po’ infantile. E poi Francis Ngannou ha una storia miracolosa. È partito dal Camerun a 26 anni, ha attraversato il deserto del Sahara e il Mediterraneo, remando con le mani, mangiando rifiuti, bevendo acqua stagnante, ferendosi l’addome con il filo spinato dei muri di confine. Voleva raggiungere l’Europa, preferibilmente l’Inghilterra, per diventare il campione dei pesi massimi di pugilato, come il suo mito Mike Tyson, ma non era abbastanza tecnico. In una banlieue parigina, dove i primi tempi ha dormito in un parcheggio, gli dicono di provare con le MMA. Lui non ne aveva mai sentito parlare prima in vita sua, sette anni dopo è diventato campione dei pesi massimi. Imparando, da zero, delle dimensioni del combattimento che gli erano estranee: nel suo ultimo incontro ha affrontato Cyril Gane, un peso massimo atipico, molto mobile, che è riuscito a rimanere fuori dalla portata delle sue mani per le prime due riprese, ma Ngannou lo ha sconfitto nella lotta a terra, lasciando a bocca aperta i giornalisti del settore (e deludendo quella parte di pubblico assetata di sangue).
È una storia possibile solo nelle MMA ormai, gli altri sport sono troppo professionalizzati, selezionano dall’infanzia. Ed è una storia che voglio continuare a seguire, che mi spinge a svegliarmi di notte senza bisogno della sveglia. Le MMA sono piene di storie così. Certo c’è l’aggressività più banale e cruda, ma ci sono anche la speranza, la resistenza, l’ostinazione, di uomini e donne che non temono il dolore. C’è l’artisticità dei corpi nello spazio, la sorpresa di gesti tecnici che interrompono la continuità dell’evento, un’intensità ansiogena, da thriller hollywoodiano, con momenti di armonia e meraviglia in grado di riscattare la violenza, di darle un senso, come dire, superiore. Molti fighter sono come dei religiosi, marzialisti stoici e umili, combattono per imparare, per forgiare il metallo del proprio talento nel fuoco della competizione. “Non mi dà gusto far male alla gente, voglio solo essere il migliore al mondo”, ha detto George Saint-Pierre, campione dei pesi welter UFC per cinque anni consecutivi – persona per bene, che ha imparato le arti marziali per difendersi dai bulli – nel documentario The Hurt Business. Gli incontri di MMA sono dei “drammi sociali spettacolari” (sempre Dal Lago), tirano in ballo l’emotività, il nostro desiderio di prendere parte, di immedesimarci in una proposta umana anziché in un’altra. Nel fighter giovane e spavaldo, magari arrogante, ma in grado di darci qualcosa in più di quello gretto, che si vede combattere solo per soldi, solo perché non sa fare altro poverino. Oppure nel fighter a fine carriera, legnoso e fuori posto finché si rivela abbastanza coriaceo e alla fine ha la meglio con l’esperienza. Ngannou e Gane erano stati compagni di palestra in Francia, forse persino amici, poi però Ngannou si è trasferito a Las Vegas e i rapporti si sono raffreddati.

Francis Zavier Ngannou. Classe 1986, noto nell’ambiente come The Predator. Alto 1,93 metri per 120 chilogrammi, la sua storia personale e il suo viaggio ai confini dell’umano dal Camerun verso l’Europa ne hanno fatto una sorta di invincibile eroe dei nostri giorni.

Francis Ngannou impegnato in un combattimento.
Nel sangue (‘sino alla morte’)
In fin dei conti è così da sempre. Giacobbe ha combattuto con Dio. Nell’Eneide il pugile Entello, anziano, sconfigge e quasi uccide il giovane Darete. Il pancrazio greco, volendo, è una forma di combattimento simile alle MMA, e nell’antichità non era raro che si combattesse fino alla morte. Il rischio era accettato. Ma le MMA moderne hanno una doppia anima: quella classica, più onorevole, e quella più spettacolare, che ha dato loro popolarità negli anni Novanta (il primo evento UFC è del 1993) quando si potevano ancora tirare i capelli e colpire i testicoli e si combatteva per vedere quale arte marziale fosse più efficace, con un’estetica da videogioco, il pugile con i guantoni contro il karateka in kimono, il lottatore di sumo a cui salta un dente per un calcio, il kickboxer cristiano che si presenta con una croce di legno sulla schiena. È uno sport identitario in cui i fighter si rivolgono prima di tutto al pubblico di connazionali, ma nato dal mescolamento di tradizioni e stili diversi, uno sport di viaggiatori, di studiosi. Forse è nel conflitto tra questi opposti, nell’impossibilità di tracciare linee di confine tra magma culturali e personali in continuo movimento, che nasce e perdura il mio interesse per le MMA. Nella complessità degli esseri umani e delle loro motivazioni, e nell’unica cosa che accomuna davvero tutti: il dolore che proviamo quando veniamo colpiti, il sangue che perdiamo quando veniamo feriti.
TRE FIGHTER, TRE STORIE
Yasubey Enomoto
Di origine giapponese e peruviana da parte di padre, quando festeggia indossa un chullo, il berretto di lana tipico peruviano, con sotto una maschera da samurai. Ha combattuto più di 30 incontri da professionista, soprattutto in Giappone e Russia, dove è stato campione dei pesi Welter della promotion M-1 e ha mandato KO un avversario sotto lo sguardo attento di Vladimir Putin, che dopo l’incontro ci ha tenuto a complimentarsi con lui. Con la sua carriera leggendaria, lontana dai riflettori dell’UFC, Enomoto rappresenta al meglio tutti quei Ronin (samurai senza padrone, considerati fuori dalla società medievale giapponese) il cui mestiere è combattere, senza borse milionarie in ballo, per l’onore e per il piacere di farlo.

Yasubey Enomoto
Stephanie Egger
“Mi piace la sfida rappresentata dal mescolare combattimento in piedi, a terra, wrestling, judo, e mettere tutte queste cose diverse insieme”. Questa dichiarazione d’amore all’unicità delle MMA l’ha rilasciata Stephanie, che giusto lo scorso ottobre ha vinto il suo primo incontro in UFC, contro la fighter americana Shanna Young, interrotto dall’arbitro a metà della seconda ripresa per una gomitata pesantissima rifilata da Egger durante le fasi di lotta a terra. Ex nazionale svizzera di judo, Egger ha lavorato nel ristorante di famiglia in un comune di meno di quattromila abitanti del Canton San Gallo e a 35 anni sta provando a farsi strada nelle gerarchie dei pesi Gallo UFC. A Las Vegas lo scorso 19 febbraio ha affrontato e battuto (in meno di quattro minuti) Jessica-Rose Clark.

Stephanie Egger

La sangallese Egger nel suo incontro (vincente) contro la statunitense Clark lo scorso febbraio a Las Vegas.
Volkan Oezdemir
Nel 2017 si è affacciato in UFC come la “next big thing” dei pesi Massimi leggeri in UFC. Nato e cresciuto a Friburgo, da madre svizzera e padre turco di origine curda, veniva da una lunga carriera cominciata nella kickboxing e proseguita nelle promotion minori. Dopo tre vittorie consecutive, di cui due nel primo round (rispettivamente dopo 28 e 42 secondi) gli è stata concessa la chance per il titolo contro Daniel Cormier, già atleta olimpico nel wrestling e una delle leggende delle MMA contemporanee. Oezdemir aveva ancora 29 anni e l’esperienza e la tecnica del veterano Cormier – che nel 2018 contemporaneamente a quello dei Massimi leggeri diventerà anche campione dei pesi Massimi – hanno avuto la meglio, mandandolo KO nella seconda ripresa. Da quell’incontro in avanti Oezdemir ha ottenuto solo due vittorie, a fronte di cinque sconfitte, ma è ancora nei primi 10 del ranking UFC e con poco più di trent’anni ha ancora tempo per tornare a puntare al vertice.

Volkan Oezdemir










