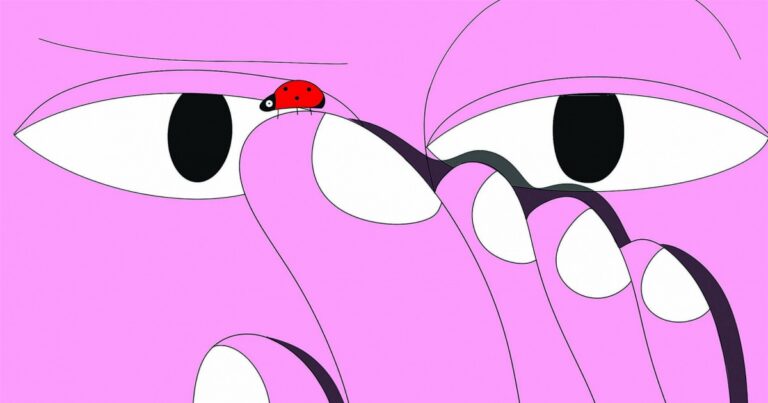Le parole del razzismo ritornano di moda

Ieri donne e omosessuali, oggi musulmani e migranti: la solfa resta la stessa, e la politica se ne approfitta
Di laRegione
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, disponibile anche nelle cassette di 20 Minuti per tutto il fine settimana.
Prima della deportazione degli ebrei, prima dei campi di concentramento, prima della Soluzione finale, prima dell’Olocausto, in Germania – ma non solo – un linguaggio sempre più crudo, antisemita e razzista ha, nel tempo, disumanizzato il popolo ebraico. «Sono i parassiti del mondo». «È colpa loro se c’è la guerra». «Sono avidi». «Proliferano come dei ratti». Venivano mostrati come esseri deformi e denigrati su cartelloni propagandistici, nei discorsi ufficiali, sulla stampa e, per finire, tra la gente.
Pochi giorni or sono si è svolta la Giornata della memoria, un appuntamento che non solo permette di tenere viva l’immane tragedia vissuta nel corso della Seconda guerra mondiale, ma ci ricorda con quanta leggerezza in molti Paesi europei quell’omicidio di massa è stato vissuto. Oggi l’ebreo non è più il «nemico pubblico numero uno». Casi sporadici a parte, l’odio verbale e scritto è indirizzato verso altre fasce della popolazione: per esempio i migranti, i musulmani, gli omosessuali. Saranno l’effetto social e l’apparente anonimato che la rete garantisce, ma l’impressione è che il senso di vergogna si stia indebolendo nell’affermare o pubblicare in rete frasi sconsiderate quali «Hitler aveva capito come risolvere il problema» e «dovrebbero annegare tutti». E che vi sia stato un netto aumento delle esternazioni pubbliche a sfondo razzista da parte anche di esponenti politici. Aspetto di per sé già preoccupante.
Ma è davvero così? Lo chiediamo a Federico Faloppa, professore di Linguistica italiana al Department of Modern Languages dell’Università di Reading (Inghilterra) e autore di saggi dedicati al tema, quali Parole contro. La rappresentazione del diverso (Garzanti, 2004), Razzisti a parole (Laterza, 2011) e Contro il razzismo (Einaudi, 2016).
«Negli ultimi anni vi sono state numerose rilevazioni e inchieste per cercare di capire se e quanto siano aumentate le dichiarazioni razziste, e in generale discriminatorie, da parte di esponenti politici. Ne è emerso un aumento, soprattutto in relazione a eventi specifici e in occasione di tornate elettorali. Evidentemente questo tipo di linguaggio paga, in termini di voti e di visibilità sui social (ma non solo). Ciò che mi allarma di più non è tanto, o non è solo, la quantità, ma la qualità e il modo. Esternazioni di questo tipo non sono certo nuove nel discorso pubblico e politico. È nuova la loro trasversalità – non solo destra estrema, ma anche esponenti di altre forze politiche –, la loro virulenza (grazie alla polarizzazione dei social, e ai commenti che possono scatenare) e la loro… normalità, o normalizzazione. Spesso non vengono stigmatizzate, come se ormai facessero parte del linguaggio politico, in tutti i registri (non più solo quello colloquiale), e a tutti i livelli. Ed è la normalizzazione, dico io, non solo di certo linguaggio, ma dell’inconsistenza argomentativa che gli sta dietro. Slogan urlati, violenti, che devono provocare reazioni per ragioni di marketing politico. Ma anche spie di un imbarbarimento generale del discorso pubblico, e del vuoto di contenuti che lo sorregge».
«Secondo un’inchiesta condotta lo scorso anno dall’Associazione Vox Diritti – che dal 2016 redige le ‘Mappe dell’intolleranza’, monitorando centinaia di migliaia di tweet che contengono alcune parole chiave legate a specifiche categorie di persone, come migrante, omosessuale/frocio, musulmano, nero, handicappato, donna, ebreo eccetera –,
se dal 2016 a oggi sono diminuiti i tweet verso omosessuali e donne, sono però aumentati nelle grandi città quelli contro gli ebrei, i disabili e soprattutto quelli contro i musulmani e i migranti. Particolarmente in corrispondenza di notizie di cronaca che li riguardano, e che sollecitano reazioni di ostilità e odio nel pubblico. Le categorie prese di mira quindi sono molte, e non sempre i dati in questo caso confortano le nostre supposizioni. Basti pensare che nel 2016 la categoria maggiormente bersagliata era quella delle donne. Ma stiamo parlando di tweet in generale, non di dichiarazioni di politici, in questo caso…».
«Certamente in Europa sta crescendo il fenomeno. Aumenta il razzismo a parole, quantitativamente e qualitativamente, e cambiano le modalità e i livelli di accettazione. Lo si vede, questo, trasversalmente nel continente. Tuttavia, grazie sia a raccomandazioni e sanzioni esplicite (per esempio in Germania) sia ad un tradizionale maggior controllo del linguaggio politico (ad esempio nel Regno Unito), in molti Paesi questo razzismo a parole, pur essendoci, non è libero di circolare nelle varietà settoriali del linguaggio tanto quanto in Italia. E non si tratta solo di leggi che lo impediscono, ma di prassi consolidate e una maggiore attenzione a non offendere attravero il linguaggio che esiste a tutti i livelli. Per contro, l’accento posto sulle migrazioni da un lato, come se fossero la causa di tutti i mali, e l’estrema polarizzazione dei discorsi pubblici e politici, favorita anche dai social media, sta diffondendo e naturalizzando il razzismo a parole in molti Paesi. E non penso solo all’Ungheria di Orbán, ma anche all’Austria, alla Polonia, ai Paesi Bassi, alla Danimarca. E chi dovrebbe fare il ‘cane da guardia’ del potere, delle forze politiche, delle istituzioni, ovvero i media, spesso funziona invece da megafono. E di nuovo si tratta di una tendenza diffusa un po’ in tutta Europa».
di colore a Chiasso. Spesso gli autori di queste esternazioni, se criticati, rispondono che sono stati mal interpretati o che si trattava di affermazioni goliardiche. C’è davvero troppa «severità» da parte dell’opinione pubblica?
«Non credo si tratti di goliardia o cattiva interpretazione. Chi dice certe cose è ben consapevole – se non lo è, meglio faccia un altro mestiere… – dei possibili risultati in termini di attenzione mediatica, di visibilità, di commenti raccolti sui social che può ottenere. Sa anche che lo stigma sociale verso certo linguaggio è meno forte che un tempo. E che quindi tutto finisce, al massimo, con un ‘sono stato frainteso’, ‘scherzavo’ ecc. Non direi, perciò, che ci sia troppa severità: semmai ce n’è troppo poca, anche se non sono convinto che il contrasto a un certo linguaggio razzista, sciatto, offensivo debba passare necessariamente dalla sanzione penale o amministrativa. Servirebbe invece un rifiuto esplicito da parte del pubblico, una reazione di condanna, e poi una damnatio memoriae verso i soggetti rei di aver fatto affermazioni di un certo tipo. Della serie: se non sai stare a tavola, è meglio che te ne vada… E questa tavola si chiama politica, senso di responsabilità, esempio morale, rappresentanza: se non ne conosci le regole, allora non ci dovresti stare… E devi essere preparato a prenderti gli sberleffi che meriti».
«Sì, sembra che non esistano più limiti: tutti possono dire tutto, anche le cose più insultanti, anche in contesti pubblici. Ecco: è come se ci fossimo assuefatti ai rumori intestinali, alle flatulenze (che si aveva ritegno di fare solo in alcuni luoghi, e da soli), ai rigurgiti peggiori. Mentre il rispetto delle convenzioni, anche linguistiche, il rispetto delle regole di un civile conversare, di una dialettica fondata sugli argomenti e non sugli slogan peggiori, sembrano essere residuali se non note di demerito. È come se avesse vinto la pancia del Paese, e non la testa: il livore sull’indignazione, la rabbia sulla protesta. E chi cerca di usare la testa, gli argomenti contro gli slogan, viene stigmatizzato come vecchiume o, peggio, come élite, intellettuale, professorone, lontano dalla ‘gente’».
«Questo è l’aspetto più preoccupante, a mio avviso. Il linguaggio d’odio, o hate speech, non è certo invenzione recente, né figlio dei social media. Tuttavia, come dice Giovanni Ziccardi nel suo libro L’odio online, vi sono alcune specificità dei nuovi media che aiutano, diciamo così, la diffusione di certe parole, di certi slogan, di certi discorsi.
Il paradosso è che, spesso, chi sbraita o incita all’odio o all’apologia di nazismo sui social crede di poterlo fare perché agisce nel suo spazio «privato» e colloquiale di Facebook, che però tanto privato e colloquiale non è. Anzi, funziona come piazza virtuale, dove si dà più ascolto, in effetti, a chi ‘urla’, non a chi bisbiglia… Ma è cambiata la società a causa di queste nuove abitudini, o sono cambiate le abitudini perché la società esprimeva già dei valori diversi? Qui il dibattito è aperto, anche se io personalmente tendo a propendere per la prima interpretazione…».
«I parallelismi storici sono retoricamente efficaci, ma spesso né ci fanno riflettere davvero sul passato, né spiegano efficacemente il presente. Victor Klemperer in Lingua Tertii Imperi (1947) descrisse molto bene il processo che, nel discorso, portò alla rapida de-umanizzazione degli ebrei sotto il Terzo Reich, alla perdita di senso di certe parole, alla manipolazione del linguaggio. Che portò, tra le altre cose, alla visione dell’ebreo come un nulla prima ancora che un nemico. Vi è questo rischio, oggi? Per fortuna non siamo in quel contesto storico. E, almeno sul piano istituzionale – intendendo con questo anche le istituzioni sovranazionali – qualche anticorpo contro i totalitarismi e gli stermini del diverso, negli ultimi settant’anni l’abbiamo sviluppato. Tuttavia, sul piano simbolico, abbiamo già prodotto una de-umanizzazione dell’altro (non da oggi) e una manipolazione linguistica che, per esempio, ha portato alla criminalizzazione del migrante in quanto migrante e della solidarietà nei suoi confronti (si pensi al discorso anti ONG oggi prevalente), alla falsificazione della realtà e dei dati (leggendo i quali ci accorgiamo che le invasioni di cui si parla tanto non esistono nei fatti),
alla declinazione di sicurezza in un solo senso, quello dell’ordine pubblico e della difesa dall’estraneo (mentre di sicurezza sociale, sul lavoro, della salute eccetera si parla più raramente). E questo ha già prodotto risultati chiari non solo sul piano del consenso e della delegittimazione del consenso, ma anche nelle vite di persone reali, in carne ed ossa: che grazie al razzismo linguistico e ai suoi frutti hanno già conosciuto un peggioramento delle loro condizioni di vita. I rischi di oggi non sono necessariamente quelli di ieri: ma sono i rischi reali di esclusione dalla cittadinanza, dai diritti e dal tessuto sociale di migliaia di persone».
«La psicologia sociale ci dice chiaramente che il pregiudizio è un filtro naturale, utile alla sopravvivenza, con cui noi leggiamo il mondo che ancora non conosciamo. È un modo per trovare delle coordinate in una terra incognita, per gestire situazioni imminenti, per allertare i nostri sensi prima di avere una conoscenza precisa dei fenomeni con cui ci misuriamo. Non dobbiamo quindi stupirci se abbiamo, o incontriamo, dei pregiudizi. È naturale averli. Mentre è meno naturale perdere tempo ad approfondire dati reali. Tuttavia, per esigenze di cooperazione, la nostra specie ha imparato nel tempo a superare il livello del pregiudizio, e a orientare le proprie scelte razionali in base alla conoscenza. Grazie alla conoscenza abbiamo tra l’altro imparato che gli stereotipi possono essere messi in discussione, e decostruiti. Dovrebbe essere proprio questo il primo passo – faticoso, impegnativo, ma necessario – per contrastare il discorso d’odio e il linguaggio razzista».