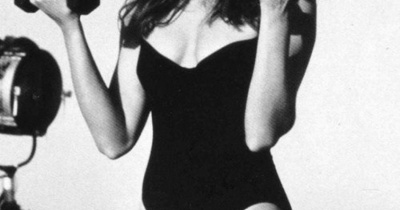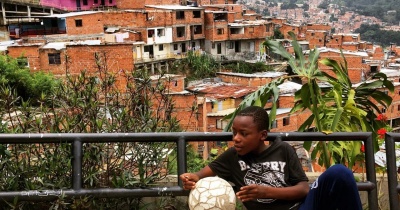Perdonare, quant’è difficile

Chi per un motivo, chi per l’altro, a tutti è capitato di trovarci nella situazione di decidere se perdonare qualcuno, oppure se vivere risentiti
Di Giovanni Luise
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione
Ci siamo passati tutti. Chi per un motivo, chi per l’altro, a tutti è capitato di trovarsi nella situazione di decidere se perdonare qualcuno, oppure se vivere nel risentimento, anziché liberarsi dalle emozioni negative che ne comporta, diventando così indipendenti dall’opinione altrui. Ma sappiamo come agisce il nostro cervello: è concepito per evitare il dolore, basandosi su esperienze passate, attuando quindi un meccanismo di non reiterazione di situazioni potenzialmente negative.
“Madre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”, esclamava un addolorato Checco Zalone nel constatare che qualcuno aveva osato gettare nella spazzatura le orecchiette fatte a mano dalla mamma e, non potendo sopportare l’ignobile gesto, se ne era andato via mortalmente offeso. Il meccanismo non funziona solo nei film.
Tempesta emotiva
Nella realtà, infatti, è estremamente raro il perdono “reattivo” o immediato, perché l’essere umano per perdonare ha bisogno di un processo metabolico fatto di tempo e di dolore emotivo. Anche quando l’oggetto dell’offesa va oltre il tradizionale formato di pasta pugliese.
Ma cosa significa realmente “perdonare”? Volendo lasciarsi dietro le definizioni classiche consultabili un po’ ovunque, perdonare può significare superare la tempesta emotiva creata dalla ferita ricevuta e nel contempo non provare più dolore, rabbia o desiderio di vendetta riuscendo infine a trasformare tali emozioni in empatia e comprensione.
Detto, fatto? Magari.
Sappiamo tutti che il processo è piuttosto complesso perché quando qualcuno ci ferisce, è fisiologico percepire risentimento verso chi ci ha fatto del male e spesso questa frattura emotiva è in grado di creare cicatrici così profonde da rendere difficile perfino considerare l’idea del perdono: ogni qualvolta ritorna in mente l’offesa, il dolore si riacutizza. Accanto alle ferite emotive, a giocare un ruolo centrale nelle dinamiche del perdono troviamo le cosiddette “credenze irrazionali”, che rappresentano delle convinzioni profondamente radicate nell’essere umano spesso limitanti, ma soprattutto non veritiere.
Irrazionalità
Una delle più diffuse è l’idea che perdonare sia un segno di debolezza. Nella nostra società la forza è spesso associata alla capacità di auto-proteggersi e di non mostrare mai vulnerabilità, per cui l’eventuale perdono sarebbe una sorta di accettazione dell’ingiustizia subita. È come se vivessimo con la costante sensazione di avere addosso una pressione sociale per non perdonare, specie quando l’offesa è grave.
Se provassimo ad andare oltre questa credenza potremmo non solo ridefinire il concetto di “forza”, ma riusciremmo a scoprire anche che il perdono è il miglior modo per riprendere il controllo della propria vita, liberandoci così dai sentimenti negativi e diventando indipendenti dall’opinione degli altri e della società.
L’altra grande, limitante, credenza irrazionale risuona pressappoco così nella nostra testa: se perdono oggi, sarò tradito di nuovo domani! La scienza ha dimostrato che il lavoro del nostro cervello consiste nell’associare la sofferenza alla persona o alla dinamica che ce l’ha creata, e tale associazione genera una specie di anticipazione di dolore futuro rafforzando la paura della ripetizione finendo così per creare tensione e vigilanza costante.
Vivere nella diffidenza
Vivere con persistente diffidenza può danneggiare sia le relazioni attuali che quelle future, impedendo la creazione di nuove connessioni basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco; il compito di ciascuno è quello di provare ad “accorgersi” di quando la mente prende il sopravvento e di non farsi travolgere dal meccanismo dell’evitamento.
Per paura di rivivere il dolore, infatti, una persona può arrivare ad evitare completamente la situazione similare che ha causato il danno; ma se questa strategia può sembrare efficace a breve termine, impoverisce drasticamente le esperienze della vita come ci insegna il classico, ma errato pensiero: “Ho preso una batosta in amore? Ecco, questa è la dimostrazione che l’amore non esiste!”.
L’obiettivo, quindi, è riuscire a superare i terremoti emotivi e le credenze irrazionali guardando il perdono per quello che realmente è: un atto di infinita forza interiore, di estremo coraggio e di profonda saggezza. Perdonare, inoltre, conviene sempre perché facilita l’“auto-perdono” che non significa sottrarsi alle proprie responsabilità o minimizzare le proprie azioni, ma consiste in un processo che parte dal riconoscimento delle proprie colpe e dall’accettazione delle proprie emozioni negative diventando cruciale sia per la nostra salute mentale che per la nostra crescita professionale.
Insomma, la scelta della strada da imboccare su come non farci travolgere dal delicato e complesso argomento, è solo nostra. Se poi non si è così convinti che il perdono abbia la capacità di migliorare più chi lo concede rispetto a chi lo riceve, si può sempre adottare l’approccio di Mafalda quando sagacemente ammette: “Sì ok, io ci metto pure una pietra sopra, ma tu… mettiti sotto”.

© Depositphotos
Perdonare o non perdonare?, questo è il dilemma