T come ‘tradurre’. Per non perdersi con le parole

Il guaio maggiore della traduzione? È che devi cominciare dalla testa (dalla tua testa); poi cerchi, come puoi, di mettere riparo a questo guaio
Di Marco Stracquadaini
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione.
Tacere
La scrittura è insocievole, è solitaria. Quella della canzone non lo è o lo è molto meno. La parola della canzone è la parola socievole. La scrittura tende all’isolamento. La canzone al contrario, almeno nella sua seconda fase, è pubblica. Quando la scrittura, l’altra, trova il destinatario, lui pure solo, è troppo tardi. La parola della canzone è la parola che non tace. Non tace in tre modi (dal che si vede che la parola scritta tace tre volte): è detta, pronunciata; non è pronunciata semplicemente, ma cantata; e poi nel concerto, nel video, vi si aggiunge l’immagine. La parola della canzone a differenza della scritta è la parola estroversa. Anche tradurre è meno insocievole che scrivere, dato che siete in due. E il traduttore è una specie di scrittore che non scrive da solo.
Tentativi
Arriva un momento in cui tradurre sembra ridursi allo scegliere tra quindi e dunque. Soltanto, solo e solamente. Adesso oppure ora, niente o nulla… La distanza tra le due o tre scelte è breve solo in apparenza. È un fatto di misure o di suoni e di qualcos’altro di più indefinibile. Al traduttore capita di vedersi cambiati dal correttore i qua in qui, spesso. Che pare un mutamento minimo, ma se il correttore corregge non lo sente così. Il qui sembra più raffinato, il qua grossolano? Forse il qua è parlato, il qui è scritto?
Tradurre consiste nel mettersi al servizio di queste giunture della lingua, si va avanti per avvicinamenti, approssimazioni e nella semi-oscurità. In questo cammino qua e là devi scegliere. Alla bontà della scelta non ti persuade nulla di razionale. Semplicemente fai un tentativo, se non ti convince ne fai un altro. Finché dici: così va bene. Perché sia la scelta giusta lo sai confusamente o non lo sai, ma non ci pensi perché in quel momento non importa. Questo potrebbe voler dire che nel tradurre entra tanta ragione quanto nello scrivere. Che lo scrivere funziona e va più o meno lontano secondo che parta poco o molto dalla testa. Se parte poco, va più lontano. Anche nel tradurre si ricorre alle facoltà della ragione fino al limite oltre il quale non cominci ad ammazzare ogni cosa, coi suoi strumenti assennati, esatti, approssimativi e corti.
Quale che sia lo stato della tua lingua, senti che in quei mattoni innumerevoli senza i quali non è possibile costruire una sola frase (allora, ecco, forse, anche, proprio, già, poiché, così, davvero…), è ancora sana. La lingua è un luogo in cui si sta, il primo luogo in cui stiamo. Siamo costretti a viverci nello stato in cui la teniamo. “Come ti rifai il letto, così vai a dormire”, dice un proverbio. Se quel luogo lo curiamo, diventa una specie di fortezza in cui andare a ripararsi nei momenti di necessità. “Raggiungibile, vicina e non perduta – scrive Paul Celan – in mezzo a tante perdite, una cosa sola: la lingua”.
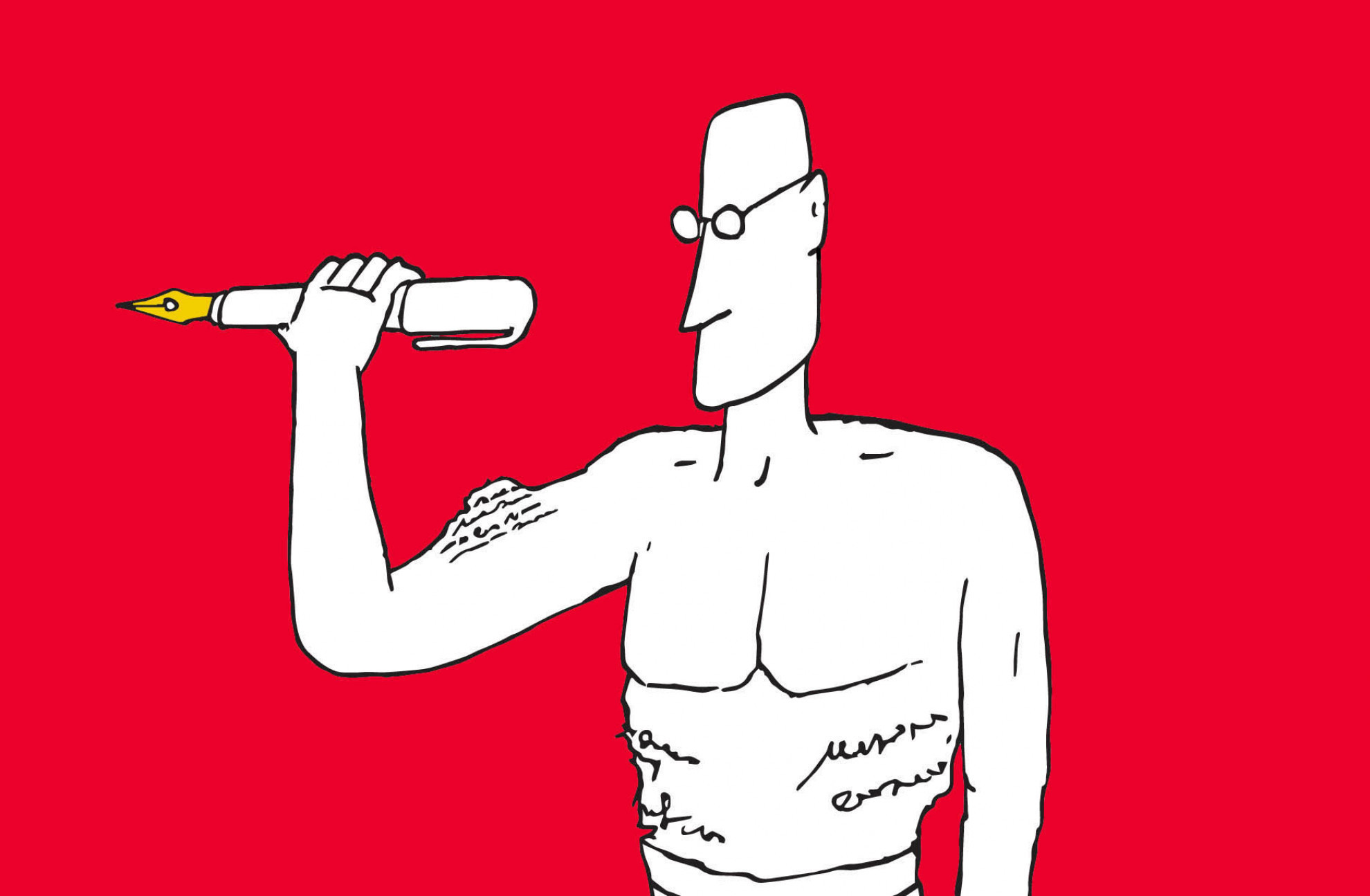
© Doriano Solinas
Testa
Un uomo si trova in un bar della catena Starbucks, a Berlino, seduto davanti a una tazza di caffè, quasi in fondo a un corridoio. Nel giro di mezz’ora vede entrare, ognuna per conto suo ma anche due insieme, sette persone che cercano il bagno. Nota che queste sette persone si comportano tutte allo stesso modo. Entrano e si dirigono, un po’ guardandosi intorno, verso il fondo del corridoio, dove si intravede un disegno sul muro. Con lo stesso passo esitante tornano indietro, perché quello non era il bagno, continuando a guardarsi intorno, ma già piuttosto sfiduciate. Poi escono. Il bagno era al secondo piano. Nessuno ha avuto il coraggio, non si sa perché, di chiedere dov’era. Ma il perché forse si sa: gli uomini e le donne in partenza esitano. Si ritrovano l’esitazione come punto di partenza. Anche i primi apprendimenti di una lingua, di un Paese straniero, accadono tra mille esitazioni, cantonate pubbliche o private, gaffe… E in una lentezza simile alla lentezza dell’apprendimento del bambino. Andare a stare in un nuovo Paese è come ricominciare daccapo a rinominare il mondo.
La nostra lingua la impariamo prima a casa che a scuola, più dalle voci che dai libri. Forse nessuno l’ha detto più brevemente di Giordano Bruno, anche se si riferiva allo stile: “Chi mi insegnò a parlare fu la balia”. Il bambino legge col dito, lentamente, pronunciando le parole. Ogni parola, ogni sillaba lo colmano, aspetta che si depositino prima di passare alle successive. Leggere lentissimamente è come scrivere ciò che stai leggendo. Leggere ad alta voce rallenta la lettura. Poi la rallenta copiare. Leggere in una lingua non propria costringe ad andar piano. Rallentando la impari come i seienni di quella lingua, per assorbimento. Il guaio maggiore della traduzione, ripeterlo non sarà superfluo, è che devi cominciare dalla testa (dalla tua testa); poi cerchi, come puoi, di mettere riparo a questo guaio.
Tic
Ogni traduttore traduce qualcosa per il puro gusto di farlo. Avendo cominciato a scrivere questa voce a penna, e rileggendo ad alcuni giorni di distanza, dove ho scritto “gusto” leggo “gesto”. Sono le buone venture della cattiva grafia. Sicché è molto meglio riprendere così: ogni autentico traduttore traduce qualcosa per il puro gesto/gusto di farlo. Tre pagine, o trenta o un libro intero. Un libro intero è più raro. A meno di NON essere un traduttore. Allora sì, puoi farlo davvero per il puro gesto/gusto. José Salas Subirat era un assicuratore argentino con la passione (o tic?) del tradurre. Tra un’assicurazione e l’altra, mise in spagnolo-argentino l’Ulisse di Joyce, a tempo perso. Un po’ come tradurre l’Uomo senza qualità o la Recherche a tempo perso. Si dà il caso che Santiago Rueda, editore argentino commerciale e illuminato, indica un concorso per una traduzione dell’Ulisse. E Salas Subirat può presentare la sua già pronta, dopo pochi giorni. La inviò, probabilmente, o la lasciò nella segreteria dell’editore. Ma è più suggestivo vederlo che si presenta da Rueda in persona col pacco sotto il braccio. Questa storia eccezionale, però, una storia di purezza letteraria, non ha bisogno di suggestioni. Così è nata la prima traduzione dell’Ulisse in lingua spagnola.
Toccare (1)
C’è qualcosa di commovente nell’atleta che ripete per ore lo stesso esercizio. Anche con dieci anni di carriera alle spalle. Ho sentito da un maestro di scherma che per imparare la tecnica della sciabola – quelle del fioretto e della spada sono meno complesse – ci vogliono cinque allenamenti a settimana per dieci anni. A un giovane che ha preso il vizio di muovere appena la spalla prima di tirare, dice, per farglielo perdere ci vuole un anno; se dopo un anno ce l’ha ancora, si lascia perdere. La semplicità dell’azione fatta con lentezza, poi più rapidamente, ma sempre la stessa. La semplicità del credere che si deve passare per quell’atto semplice, e per tutti gli altri simili, per mirare all’impeccabilità. È forse anche questo una rinuncia a sé. Dipendere da un atto elementare che in quel momento ha tutto il comando. Per il tempo della preparazione, non ci si appartiene, in vista della gara in cui si spera di appartenersi al più alto grado possibile. Ma, anche lì, dov’è l’oggetto dell’azione? Forse a metà strada tra lui – l’atleta – e il mondo esterno. Ancora fuori di lui. Lui però ne tiene un’estremità. La gara è il tempo del contatto. Bisogna essere all’altezza di un evento così raro: noi che tocchiamo il mondo fuori di noi.
Toccare (2)
Tradurre è un atto che assomiglia ai più essenziali atti della vita. Agli atti, ai gesti che ci mettono in contatto col fuori da noi. Non facciamo che tradurre costantemente il mondo che è fuori nel mondo che abbiamo dentro, e viceversa. Quando guardo, traduco. Traduco quando ascolto. Quando parlo. Le parole sono il noi fuori di noi. Con le parole tocchiamo il mondo, e il mondo può toccarci. Sono come un tatto pubblico. Un surrogato del tatto. Quando traduci senti che puoi essere gli altri e che gli altri, di là dalle differenze, sono te.
Toccare (3)
Sono curiose le introduzioni che stroncano il libro che introducono. Alcune, oltre che stupirti o divertirti, ti scoraggiano del tutto. Per anni mi è stato impossibile leggere le Odi di Orazio per il tenore dell’introduzione di Ramous che ne è anche il traduttore. L’album fotografico su Hesse, presentato da Chiusano, ho deciso di regalarlo perché letta l’introduzione, molto bella, sapevo che non l’avrei più riaperto. Il saggio di Sartre su Jules Renard (o i saggi?), per definirlo non c’è altra parola che demolizione. Editori italiani, col candore più grande del mondo, lo prendono e lo mettono all’inizio di Poil de carotte o di una scelta del Journal. Le parole di Carena sui Ricordi di Marco Aurelio hanno lasciato segni più fuggevoli (anche quelle di Sartre su Renard), perché niente finora può incrinare ai miei occhi quel libro. Dopo un’illustrazione di che cos’era lo stoicismo, prima di una mezza pagina finale piuttosto lusinghiera, Carena pare commiserare l’autore tutto il tempo. L’elenco si può allungare certamente. Si può tradurre un autore, mi chiedo di riflesso, una scrittura, senza amarla? O senza in qualche modo esserne coinvolti, toccati? O che incuriosisca, che muova qualcosa dentro di noi, anche confusamente? In una scrittura già da noi giudicata o sentenziata, che nemmeno la detestazione può più avvicinarci, è possibile entrarci in modo vitale, ritrasmetterla vitalmente?

© Shutterstock
Trasformare
Quando penso a Vittorio Sereni prigioniero in Algeria, mi viene in mente che negli stessi mesi Ennio Flaiano era prigioniero in Etiopia. Sereni dice che non aveva mai pensato di tradurre poesia, fino a quando un compagno di prigionia gli dà un foglio in cui ha tradotto, seguendo la lettera, The Conqueror Wor di Edgar Allan Poe, e gli chiede di farne di nuovo dei versi confrontando l’originale. Negli stessi mesi o negli stessi giorni, in Etiopia Flaiano traduceva Il corvo. Pensi ai poeti nelle carceri e nelle trincee occupati a cavare dal male il bene. A José Hierro incarcerato a 17 anni, e fino a 21, che in prigione scrive due delle sue poesie più belle, Canción de cuna para dormir a un preso e Reportaje. Non si tratta d’altro; non di cercare una vaga consolazione, ma letteralmente di “questo essenziale compito umano” (Sergio Solmi), trasformare il male in bene. In certi periodi più che in altri, bisognerebbe rinchiudersi a tradurre, imprigionarsi di proposito come quei poeti prigionieri; come i monaci che si ammazzavano a copiare, che si sono ammazzati a copiare per secoli.
Tre (dimensioni)
Che cosa si può scrivere senza costrizioni, senza limiti? Male che va ti soffocano, ti strozzano e ti impediscono di scrivere o di fiatare. Che non sarebbe l’ultima virtù degli obblighi a cui deve legarsi lo scrittore. Sonetti splendidi, in un mare di altri illeggibili, penosi. Il sonetto fallito ti fa sentire dentro una gabbia. Quello riuscito in un bellissimo chiostro, aperto verso il cielo. Che cosa si può fare nella vita senza costrizioni? Ti aggiogano e ti aprono la strada. Tu da un lato, dall’altro le cose, il mondo; dall’altro, che è lo stesso, le persone. Tu sei una di queste tre dimensioni. Che cosa puoi fare da solo, e senza quei due limiti certi?
Niente. Balbettare.
Tedesco (un)
“Le cose bisogna farle adacio – diceva un tedesco – allaccia un pottone, poi, spetta poco, allaccia l’altro pottone, poi, spetta poco…” (Carlo Dossi).







