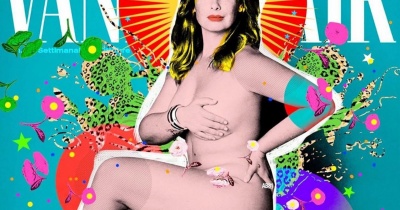I miti del jazz. Hank Mobley, il tenore invisibile

La storia della musica nasconde innumerevoli paradossi. Come le vicende e i mancati riconoscimenti (in vita) di questo talentuoso sassofonista dimostrano
Di Fabio Martini
Pubblichiamo un articolo apparso su Ticino7, allegato a laRegione.
A volte le qualità artistiche e musicali non bastano. La vicenda personale di Hank Mobley (1930-1986), sassofonista tenore e improvvisatore di straordinarie capacità, potrebbe essere riassunta nelle seguenti parole: la sorte non di rado allontana gli uomini da quello che avrebbe potuto essere un percorso costellato di soddisfazioni e successi. Nato in Georgia, il cuore “nero” degli Stati Uniti e lo Stato confederato in cui nel settembre del 1864 si erano decise le sorti della Guerra civile, la famiglia di Hank Mobley, come molte altre famiglie di colore del Sud, si era trasferita a Elizabeth, uno dei sobborghi di New York. L’occasione di diventare musicista si presentò durante l’adolescenza: costretto a casa da una malattia, per tenerlo occupato, una parente gli regalò un sassofono. Fu un incontro fatale che lo spinse presto a chiedere l’ammissione alla scuola di musica di Newark, dove non fu accettato in quanto non residente in città. Ma il sassofono stava diventando tutto per lui: iniziò a studiare da solo, tenacemente, ascoltando i dischi che giravano in casa ed esibendosi nei complessi di quartiere e non ci volle molto perché il suo indiscutibile talento emergesse. La voce cominciò a girare e giunse alle orecchie di Dizzy Gillespie e Max Roach, sempre attenti ai giovani musicisti.

Hank Mobley, allʼanagrafe Henry Mobley (1930-1986). Per il critico Leonard Feather fu ‘il campione dei pesi medi del sax tenore’, una via di mezzo tra John Coltrane e Stan Getz.
Un ingaggio pericoloso
Le premesse erano ottime. Entrato nel giro “grosso”, iniziò a suonare nei locali di New York con i giganti del periodo: Art Blakey, Horace Silver, Kenny Dorham, Freddie Hubbard, Sonny Clark, Wynton Kelly e Philly Joe Jones, oltre a formare una solida partnership con un altro grande e sfortunato musicista, Lee Morgan, di cui di recente si è scritto su queste pagine. Si trattava di una sfida non facile per un giovane sassofonista tenore: la concorrenza era tremenda, Sonny Rollins e John Coltrane dominavano letteralmente la scena e nuovi talenti, fra cui Wayne Shorter e Archie Shepp, si profilavano all’orizzonte. Dopo l’incisione di Soul Station (1960), forse il suo album più celebre, gli fu chiesto di entrare a far parte del quintetto di Miles Davis in sostituzione di John Coltrane. Poteva rappresentare il culmine della carriera ma in realtà si trasformò in un dramma: la critica non gradì, definendolo un “peso medio” e non all’altezza del musicista di Hamlet. Anni dopo, nel 1973, Mobley, in una pregnante conversazione con lo scrittore John Litweiler, diede voce a quel momento di disperazione con le seguenti parole: “Quando ho lasciato Miles ero talmente stanco della musica, talmente stanco del mondo intero, che non mi restò che la droga”. È importante ricordare che in quel periodo si era nel pieno dell’era hard-bop, un genere musicale che rappresenta una sorta di linea di confine fra la tradizione del jazz classico e le forme più avanguardistiche sfociate a breve, grazie a figure come Coltrane, Ornette Coleman e Cecil Taylor, nel free jazz. In questo scenario, Mobley dimostrò di sapersi muovere con sicurezza su entrambi i fronti, come attesta la partecipazione alla registrazione di A Poem for Malcolm (1969) di Archie Shepp.

Hank Mobley e Alfred Lion durante le registrazioni di ‘Soul Station’, nello studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs (New Jersey, 7 luglio 1960).
Gli ultimi anni e la fine
Dotato di un fraseggio lirico, che attingeva a piene mani al blues, e di un timbro schietto e avvolgente – ascoltate la versione di “Darn That Dream” dall’album Poppin’ insieme al baritonista Pepper Adams –, restituiva al pubblico attraverso il suo sound un’ardente energia. Ma Mobley fu anche un compositore prolifico: i suoi temi, sia sul piano dello sviluppo melodico sia per quanto concerne la struttura armonica, sono un esempio di freschezza ideativa pur restando saldamente nei canoni del genere. A partire dalla seconda metà degli anni Settanta la situazione per lui si fece difficile: ammalato a causa dell’abuso di sigarette e di stupefacenti, iniziò a soffrire di seri problemi polmonari vivendo in condizioni di miseria e spesso senza un tetto sulla testa. Gli ultimi, sporadici ingaggi furono all’Angry Squire di New York il 22 e 23 novembre 1985 e l’11 gennaio 1986 con il quartetto del pianista Duke Jordan. La fine lo colse pochi mesi dopo a seguito di una crisi respiratoria dovuta a una polmonite.

L’EREDITÀ DI HANK
La recente pubblicazione da parte della Mosaic Records di un cofanetto di otto cd dedicati all’opera di Hank Mobley – The Complete Hank Mobley Blue Note Sessions 1963-70, disponibile anche su Spotify – permette di approfondire la conoscenza non solo di uno dei maggiori sassofonisti del jazz moderno ma anche di conoscerne la storia emblematica e tragica. Si tratta di tredici sessioni di registrazione, prodotte nell’arco di otto anni, dal 1962 al 1970, da cui dovevano scaturire ben dodici album (ne furono realizzati in realtà solo sette). Dalle ultime registrazioni, a cui partecipò il giovane Herbie Hancock, pur con tutta l’energia e la limpidezza ideativa di cui Mobley era dotato, traspare una sorta di rarefatta anticipazione della fine: i suoi modi si fanno più aspri e spigolosi, quasi a voler contrastare l’imminenza di eventi avversi. Vi si avverte la frustrazione di chi, pur avendo avuto tutte le carte in regola per diventare un grande, era stato costretto nelle retrovie. Ma del resto è proprio il dolore, il blues, la componente essenziale del jazz, forma di liberazione e riscatto dell’anima umana gettata nel mondo e obbligata ad affrontarne giorno dopo giorno le avversità.