La linea del tempo e il ‘sé narrativo’
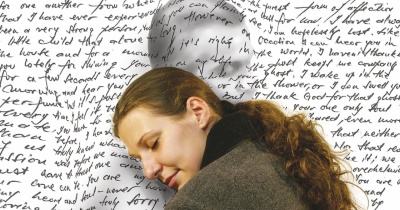
La nostra vita raccontata a noi stessi. Ecco perché è utile mettere nero su bianco i fatti della propria esistenza (o quelli che ricordiamo)
Di Mariella Dal Farra
Pubblichiamo un articolo apparso su Ticino7, allegato del sabato a laRegione.
Cʼè una procedura che qualche volta gli psicoterapeuti propongono ai loro pazienti all’inizio di un percorso: si chiama ‘la linea del tempo’ ed è un esercizio molto semplice. Consiste nel tracciare un grafico cartesiano dove lʼasse orizzontale rappresenta il tempo e quello verticale il gradiente (positivo, neutro o negativo) di un evento. Il terapeuta chiede alla persona di collocare nellʼarea del grafico quelli che ritiene essere gli episodi più salienti della sua esistenza fino a quel momento. Quello che segue, di solito, è molto interessante…
Dapprima con mano incerta, poi più sicura, la persona inizia ad annotare gli episodi più salienti della sua vita: come il trasferimento in un’altra città, la separazione dei genitori, la morte di una nonna, la nascita di un fratello… Alcuni fatti vengono cancellati, spostati in avanti o all’indietro, più in alto o più in basso: il primo giorno di scuola, “quando la mia squadra ha perso il torneo di pallavolo”, “quella volta che sono scappato di casa”… la scala del tempo viene accorciata o allungata (“quell’anno lì sono successe un sacco di cose importanti”) e gradualmente la rappresentazione sinottica della storia di vita della persona assume una conformazione più precisa. Emergono le pietre angolari, i punti di svolta, gli iati, brevi o lunghi, in cui apparentemente non accade nulla, e mentre la persona è impegnata a registrare in maniera puntiforme i ricordi selezionati, capita anche che tracci delle connessioni fra gli eventi, oppure che ne colga di nuove per la prima volta in quel momento. I punti si uniscono e formano figure, sequenze, trame, e da queste scaturiscono significati, interpretazioni, letture, anche contraddittorie, di quanto è accaduto e perché. E si aprono le sliding doors di come le cose sarebbero andate “se avessi inviato la candidatura per quel lavoro in un altro paese” o “se quella sera non fossi andato a quel concerto, dove poi ho conosciuto mia moglie”.
Tessere l’esistenza
Secondo Michele Crossley, autrice di un’introduzione alla psicologia narrativa (Introducing narrative psychology, McGraw-Hill Education, 2000), “la nostra esperienza assume automaticamente una forma temporalmente articolata nella quale futuro, presente e passato si determinano reciprocamente come parti di un tutto”, ragione per cui la psicologia umana avrebbe una struttura essenzialmente narrativa. Tuttavia, “il testo letterario trasmette un senso di struttura e di ordine perché gli eventi che formano la storia sono stati messi lì dall’autore mentre gli elementi contraddittori o incoerenti sono stati eliminati. Al contrario di quanto avviene nell’accurata composizione di una storia, la vita non può vantare questo tipo di struttura. […] mentre la storia ha un contratto implicito con l’ordine, la vita non ha niente del genere”. Cionondimeno, nel momento in cui, immersi nel flusso di coscienza del nostro dialogo interiore, ci raccontiamo quello che abbiamo vissuto, o lo riportiamo ad altri, ci comportiamo un po’ come degli autori, selezionando od omettendo in maniera più o meno conscia alcuni elementi, alla ricerca istintiva di una migliore coerenza interna. “Dettagli discordanti non vengono tagliati fuori ma semplicemente spinti sullo sfondo, messi in serbo per dopo, ordinati per importanza. E di chi è la voce del narratore che dà conto di tutto questo? La nostra, naturalmente. Nel pianificare i nostri giorni e le nostre vite, noi componiamo le storie e i drammi che metteremo in atto determinandone il punto focale e l’intento, in base ai quali distinguere fra figura e sfondo” (Carr, 1991).
In questa prospettiva, l’identità personale è una sofisticata narrazione che andiamo abilmente intessendo da quando abbiamo preso coscienza di esistere (quindi a partire più o meno dai tre anni di età). È una storia che raccontiamo e perfezioniamo continuamente, a beneficio di noi stessi e degli altri, apportando ogni volta impercettibili aggiustamenti di cui non siamo neppure consapevoli. La memoria, sulla quale il senso d’identità personale si fonda, non è infatti quell’elegante libreria statica che ci piace immaginare, bensì un processo di adattamento continuo ai dati esperienziali che in ogni momento vengono integrati al fine di mantenere una coerenza di significato interna: il fil rouge che si diparte dal momento in cui per la prima volta ci siamo riconosciuti allo specchio fino alla rappresentazione attuale di noi per come ci conosciamo.
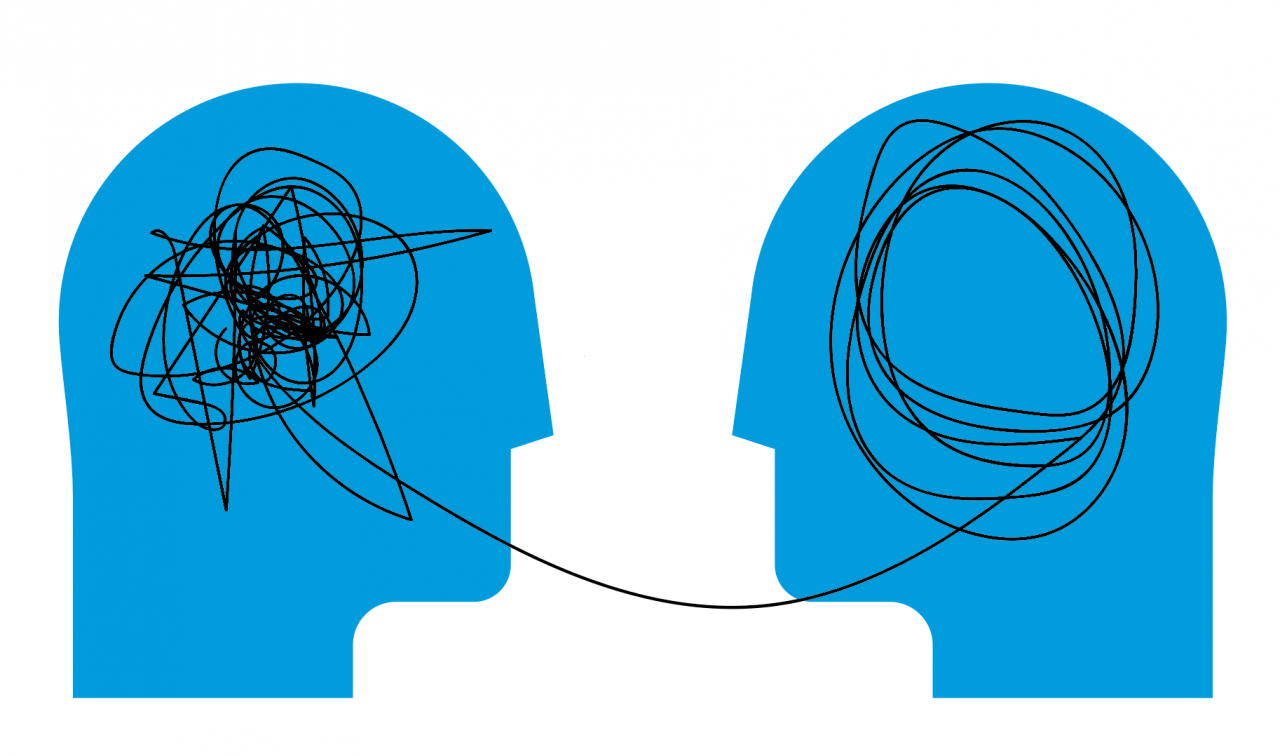
Ricomporre il tutto. O almeno provarci
Questo filo rosso scorre in filigrana attraverso l’esperienza quotidiana e vi siamo così abituati che neanche ce ne accorgiamo. Tipicamente, è solo a fronte di un evento traumatico, suscettibile cioè d’imporre una discontinuità nello svolgersi del “discorso”, che ne diventiamo drammaticamente coscienti. È il caso, per esempio, di quando si riceve una diagnosi infausta: un avvenimento sconvolgente viene a interrompere la nostra routinaria attitudine a proiettarci verso il futuro. In alcune circostanze, quando per esempio il trauma viene sperimentato in età infantile o adolescenziale, quando viene reiterato nel tempo, quando è di natura relazionale, il suo effetto “dirompente” può essere tale da determinare delle discontinuità anche a livello dell’identità personale, la cui “narrazione” viene per così dire scissa in trame diverse. È il caso del disturbo dissociativo dell’identità, precedentemente noto come disturbo da personalità multipla, nel quale l’individuo sperimenta una frammentazione del senso d’identità personale. Le amnesie, le fughe dissociative, il percepire dentro di sé “voci” che non vengono riconosciute come proprie (per esempio, quella di un bambino) sono tutti sintomi di una difficoltà a integrare in un senso di sé “unitario” parti di un’esperienza che, non potendo essere metabolizzata, viene di fatto dissociata. Nei casi più severi, queste “parti” dissociate possono organizzarsi in identità parzialmente autonome, ciascuna con la propria “storia di vita”, dove le diverse “versioni” del sé corrispondono spesso agli aspetti inconciliabili di una stessa vicenda. Di qui la valenza fortemente terapeutica, per le persone che hanno subito un trauma psicologico, di arrivare a raccontare in maniera integrata quanto è accaduto loro in modo da ripristinare quel senso di continuità “storica” su cui, metaforicamente, poggiamo i piedi. E nel riallacciare quel filo che si era spezzato, scoprire nuovi significati, elementi inediti, un diverso punto di vista…
La ʻqualità’ dei temi
Ma il modo in cui raccontiamo noi stessi e la nostra storia non è importante solo nel caso delle esperienze traumatiche: la qualità di questa narrativa autobiografica “implicita” tende a “informare” trasversalmente il senso di benessere e realizzazione personale. Esaminando gli studi svolti sull’argomento, un gruppo di ricercatori (Adler et al., 2016) ha individuato quattro elementi ricorrenti: due di tipo tematico (temi affettivi e motivazionali) e due “di processo” (integrazione del significato e grado di strutturazione), ciascuno dei quali risulta correlato al benessere psicologico.
I temi affettivi sono la componente emotiva della narrazione e tendono a cambiare dall’inizio alla fine della storia, polarizzandosi tipicamente sulla dinamica del riscatto individuale (movimento dal negativo al positivo) o della contaminazione (dal positivo al negativo). Anche i temi motivazionali sono molto frequenti e sembrano oscillare fra senso di efficacia (autonomia, auto-determinazione) e senso di appartenenza (rapporti interpersonali, comunità). Il modo in cui i nuovi dati esperienziali vengono integrati nell’ambito della “storia” può privilegiare un processo di “assimilazione” (che tende a lasciare invariata la trama preesistente) oppure di “accomodamento” (che richiede una revisione, parziale o sostanziale, della trama sviluppata fino a quel momento al fine di capitalizzare le nuove informazioni). Infine, il grado di strutturazione indica la coerenza interna della storia, il suo essere consequenziale e non (eccessivamente) contraddittoria, come invece capita quando il sé è traumatizzato.
Una ricerca estensiva (McLean et al. 2019) ha posto a verifica la relazione fra queste caratteristiche e il benessere psicologico, con risultati in parte inaspettati. In primo luogo, i temi affettivi declinati sulla dinamica del riscatto sono quelli che correlano maggiormente con la salute mentale, cosa che non stupisce considerata la centralità delle emozioni nella nostra economia psichica e il senso di direzionalità conferitoci dall’avere una motivazione. Al contrario, il grado d’integrazione del significato risulta importante per lo sviluppo dell’identità, ma non comporta automaticamente dei vantaggi. “Possiamo comprendere noi stessi e il nostro passato, ma questa comprensione non garantisce benessere, a meno che non si accompagni a un’interpretazione positiva di quanto è accaduto” (McLean et al., “The structure of narrative identity”, Journal of Personality and Social Psychology, pag. 44).
PICCOLI E GRANDI MITI
La tendenza a “raccontare storie” è connaturata all’essere umano, avendo noi una mente simbolica organizzata in forma linguistica. Si parla a tale proposito di “funzione mitopoietica” dell’inconscio, ovvero della capacità – o necessità – d’inventare miti e leggende che interpretino – e dunque mettano ordine – nell’apparente caoticità dell’esperienza quotidiana. Non a caso, quando raccontiamo una nostra vicissitudine a qualcuno, tendiamo a definirla “un’Odissea”…
LA STORIA CHE CI SALVERÀ
La psicologia narrativa è un orientamento, configuratosi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, che studia come gli esseri umani “fabbrichino” storie per comprendere la propria esperienza. L’espressione è stata coniata dallo psicologo Theodore R. Sarbin (Narrative psychology: The storied nature of human conduct, Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group, 1986) secondo il quale la narrativa è “il principio organizzatore” dell’azione umana”, in quanto gli esseri umani cercano continuamente d’imporre una struttura al flusso dell’esperienza. In questa prospettiva, l’auto-dissimulazione, la tendenza cioè a nascondere aspetti di noi stessi giudicati negativi o “inconciliabili” è una “competenza” al servizio del mantenimento (o potenziamento) della propria identità narrativa. Si tratterebbe cioè di una ricostruzione della propria storia ad opera della persona che ne è protagonista.
Muovendo da questa considerazione, un altro autore (Murray M., Narrative psychology and narrative analysis, 2003) afferma che “attraverso la narrativa, non ci limitiamo a dare una forma al mondo e a noi stessi, ma ne modifichiamo le caratteristiche in accordo alla trama che stiamo seguendo”. Spingendosi ancora oltre, McAdams et al. (Identity and story: Creating self in narrative, American Psychological Association, 2006) sostengono che le persone conferiscano senso alla propria esistenza attraverso la costruzione e l’interiorizzazione di storie che ci definiscono a partire dall’adolescenza e dalla prima giovinezza, e che quindi “le nostre vite potrebbero essere il prodotto delle storie che raccontiamo”.







