Semi acciaccati. La crisi della fertilità maschile
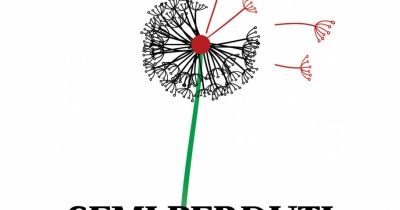
Bassa la qualità dello sperma svizzero. C’entra lo stile di vita, ma si sospettano anche alcune sostanze chimiche. Le lobby fanno ostruzionismo.
Di laRegione
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, disponibile anche nelle cassette di 20 Minuti per tutto il fine settimana.
Lo sperma dei giovani maschi svizzeri è tra i peggiori d’Europa, alla stregua di danesi, norvegesi e tedeschi. La nuova conferma è giunta a fine maggio da un gruppo di studiosi di Ginevra che hanno analizzato il liquido seminale di 2’523 reclute 18-22enni. La concentrazione media di spermatozoi per millilitro, la loro mobilità e morfologia sono al di sotto degli standard minimi dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’Ufficio federale della sanità pubblica ha comunicato che indagherà quali «sostanze nocive» sono alla base del problema. Eppure le cause, come certe sostanze chimiche tossiche per la riproduzione e il sistema ormonale, sono almeno in parte già note. Cosa frena la ricerca? E qual è il ruolo dell’industria chimica?
Non è la prima volta che la Svizzera studia il problema. La «bassa attività testicolare» dei giovani svizzeri «dovrebbe essere riconosciuta come una questione di salute nazionale», affermava già il Programma nazionale di ricerca 50. C’è motivo di temere che certe sostanze chimiche prodotte dall’industria e rilasciate nell’ambiente siano tra le cause, ma come si spiega che nel 2019 ancora manchino conferme scientifiche condivise da tutti?
Secondo alcune ricerche Usa, uno dei motivi è a monte: mancano specialisti e borse di ricerca. In pratica «la letteratura medica si è tradizionalmente focalizzata sull’infertilità dal punto di vista femminile», si legge. Ce lo conferma anche il dottor Alessandro Santi, primario al Centro cantonale di fertilità all’EOC: «In effetti la diagnostica e soprattutto i trattamenti per l’infertilità degli ultimi 40 anni sono concentrati quasi esclusivamente sulla donna», dice. Lo stesso curatore dello studio ginevrino, il genetista Serge Nef, ci spiega che l’andrologia «non è un tema di grande successo», forse perché «per evitare di nuocere alla virilità dell’uomo», la donna «è stata spesso incolpata per i problemi d’infertilità di coppia». Nef non ci ha saputo dire quanto s’investa nella ricerca in andrologia o in urologia in Svizzera, né quanti ricercatori ci siano. Se non si sanno queste cose, forse il tema è davvero snobbato. In Svizzera mancano persino laboratori: senza quelli francesi e danesi lo studio ginevrino non sarebbe stato possibile.
Secondo Santi «le ricerche sono rese difficili anche dalla forte eterogeneità delle possibili cause». È vero, i sospettati sono tanti: dal fumo in gravidanza (vedi pagina 7) ai metalli pesanti (piombo), fino alle sostanze chimiche cosiddette perturbatori endocrini (PE) come gli ftalati (nella plastica) o i pesticidi (nell’agricoltura). Fino a pochi decenni fa un farmaco contro gli aborti spontanei, il Distilbène, era finito sul banco degli imputati: i nati tra gli anni Quaranta e Ottanta vennero massicciamente esposti. Risultato: patologie ai testicoli e danni alla qualità dello sperma nei nascituri maschi. Il farmaco fu bandito. Lo stesso accadde col piombo prodotto dall’industria e contenuto nel carburante fino agli anni 90: il suolo ticinese ormai ne è zeppo, dice un rapporto cantonale, ma poi arrivò la «benzina verde».
E se la sigaretta è ancora perfettamente legale, lo sono anche i famigerati PE. Queste sostanze sono onnipresenti negli oggetti di plastica di uso quotidiano, nell’aria, nel suolo, nell’acqua e quindi anche nel cibo e nei nascituri. Eppure la scienza ne deve ancora indagare molti effetti: com’è possibile? Il paradosso vale anche coi pesticidi. La Svizzera, che ne è una grande produttrice, di recente ha deciso di vietare quelli più tossici, però l’industria nazionale può esportarli: è un controsenso, ma la legge lo permette. Insomma, se la priorità è la salute pubblica, sembra che gli interessi economici dell’industria, che ha enormi responsabilità, la facciano franca. Cosa non funziona?
«Le aziende chimiche hanno ignorato la legge per anni e se la sono cavata» ha denunciato di recente l’associazione ambientalista tedesca Bund con l’European Environmental Bureau (EBB). Motivo: ben «due terzi» delle 700 sostanze segnalate dalle industrie – perlopiù tedesche e britanniche – in tutta impunità non rispettavano la normativa di sicurezza UE 1907/2006, in gergo REACH, una banca dati che registra, valuta, autorizza e limita le sostanze pericolose. Nella lista ambientalista figurano 654 aziende e 41 sostanze «non conformi», tra cui il «dibutil-ftalato» (o DBP), un famigerato PE, che è tutto fuorché illegale. Lo possono produrre pochissimi giganti della chimica.
Ogni anno l’Agenzia europea dei prodotti chimici, l’ECHA, ha a che fare con tonnellate di nuovi composti industriali. Alcuni plastificanti, solventi, additivi, collanti, pesticidi ecc. sono «estremamente preoccupanti» per l’uomo, perché «cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione» (CMR in inglese). Per questo in teoria l’industria dovrebbe rispettare le regole, ma in pratica non lo fa. Per molti critici la banca dati REACH è una buona idea, ma non funziona: la si riempirebbe «con qualcosa, anche se di scarsa qualità», perché l’ECHA starebbe «dalla parte dell’industria», denuncia la Ong CHEM Trust. «Stiamo lavorando per diventare più efficienti» ha reagito all’inchiesta tedesca l’ECHA. «Saremo completamente trasparenti» e rimedieremo «laddove sarà appropriato», ha aggiunto la lobby europea del Consiglio Industrie Chimiche (CEFIC).
Berna già si adegua alle decisioni dell’ECHA e vorrebbe aderire a REACH, eppure siamo gli unici a starne ancora fuori e gestiamo un nostro registro, l’Organo di notifica per prodotti chimici a Berna cogestito dall’Ufficio di sanità pubblica. Altri Stati non Ue (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) hanno recepito interamente REACH, perché noi no? L’enorme export chimico svizzero, il primo della bilancia commerciale e il secondo verso l’Ue solo dopo gli Stati Uniti, c’entra qualcosa. Non a caso la potente lobby «ScienceIndustries» si è sempre opposta a REACH, col beneplacito di Berna.
Nel 2012 si negoziò per ridurre i rischi chimici in concerto con l’Ue: la lobby chiese di «non inserire sostanze» molto preoccupanti nel diritto svizzero. Mentre scriviamo 12 sostanze PE e CMR sono già regolate nell’Ue, ma non in Svizzera. Nel 2013 Berna si espresse su REACH, dicendo che «non può (…) giudicare preponderante» il diritto all’informazione della ricerca pubblica rispetto «agli interessi dei fabbricanti» per i nuovi composti chimici, e che REACH «richiederebbe un investimento considerevole» alle aziende. Prevale il segreto scientifico.
Tra i lobbisti a Berna spicca una certa Magdalena Martullo-Blocher, la miliardaria consigliera nazionale, vice-presidente dell’Udc, presidente di EMS Chemie e membro del Cda della lobby. ScienceIndustries non ci ha spiegato perché non vuole REACH, né cosa pensa delle sostanze pericolose per il sistema riproduttivo. La portavoce Sabrina Ketterer ci rimanda a un vecchio comunicato: bisogna «basarsi su risultati scientifici, tenendo conto dei loro benefici per la società», inoltre «la dose è decisiva per gli effetti degli interferenti ormone-attivi». Sarà, ma secondo alcune Ong le lobby europee come CEFIC, ECPA (pesticidi) e PlasticsEurope farebbero di tutto per «stravolgere e indebolire» la ricerca scientifica, così da influenzare l’ECHA. Come? Introdurrebbero nei loro studi criteri «non scientifici».
La banca dati Ue condivisa tra l’industria e l’autorità pubblica funzionerebbe se ci fosse trasparenza e cooperazione, ma è opaca e dà fastidio. «Le autorità svizzere non hanno alcun accesso alle informazioni di REACH», ci conferma Daniel Dauwalder, portavoce dell’UFSP. Peggio ancora, fatta eccezione per i pericolosi CMR, continua Dauwalder, abbiamo informazioni «sui prodotti messi sul mercato in Svizzera, ma non su quelli esportati» nell’Ue dai nostri colossi chimici.
È paradossale che Berna resti all’oscuro, ma è il prezzo da pagare stando fuori dall’Ue, quindi anche dall’ECHA. Ma se tra le 654 aziende «non conformi» per gli ambientalisti tedeschi non ci sono ditte svizzere, come esportano queste ultime? E rispettano davvero le regole?
«Forse ci sono, ma l’informazione non è pubblica» ci dice Tatiana Santos di EBB. La nostra industria si serve di «rappresentanti esclusivi» nell’Ue: sono loro che si occupano di REACH ed ecco perché i nomi svizzeri non figurano.
Ma non vuol dire che non ci siano, considerando l’enorme export. Si scopre facilmente nel web che un’industria di Berna tratta un composto tra le 41 sostanze «non conformi» e lo commercia nell’Ue coi suoi rappresentanti. A trattare il DBP non sono solo poche aziende Ue (una tedesca, una ceca) e non Ue (Stati Uniti), ma anche svizzere, come una di Appenzello e una di San Gallo con filiali in Europa. Quasi tutte quelle non svizzere hanno filiali fuori dall’Ue, cioè in Svizzera. Il motivo? Alcuni esperti spiegano che conviene: costa meno esportare, c’è meno burocrazia rispetto a REACH e decisamente più segretezza sui composti. Ci restano allora notevoli dubbi. L’industria chimica la farebbe franca a spese della nostra misera fecondità? Forse l’inquinamento chimico in Svizzera è più grave di quanto si creda?






