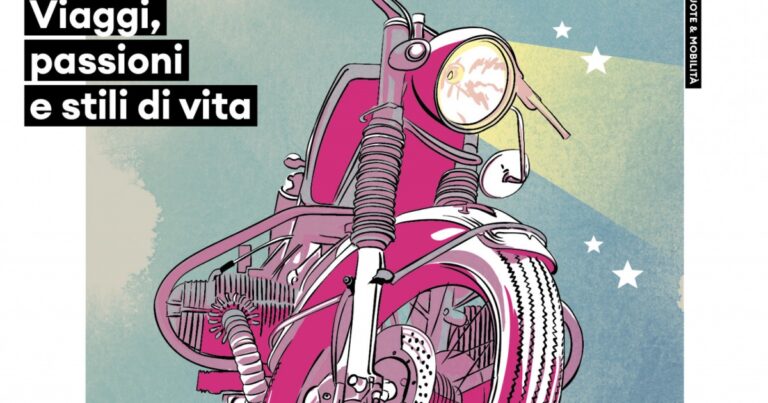Il Blinnenhorn. Una montagna tra Vallese e Piemonte

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, disponibile anche nelle cassette di 20 Minuti per tutto il fine settimana.
Di laRegione
Qualcuno ha scritto che dalla sua sommità la veduta è ‘splendida’: un aggettivo che riassume solo in parte il fascino di queste cime sul confine italo-svizzero.
O Blindenhorn, Corno cieco. Nome o traduzione un po’ goffa del nome di una montagna la cui fama deriva piuttosto dalla vista che si gode dalla sua vetta. Blinnenhorn,
volto in Blindenhorn o più familiarmente in Blinden, sembra più plausibilmente derivato da Blinnental, la valle che ne discende a nord-ovest, forse cieca non avendo sbocchi transitabili in alto.
O forse chissà perché. Ma non staremo qui a fare storie per il nome di una montagna che in molti ricordano ammantata di neve, e che ormai nelle nostre estati perenni, per essere salita dalla via normale della Val Formazza – quella che sale dal rifugio Claudio e Bruno – non necessita quasi più di ramponi e piccozza, come scrive bene Marco Volken nel suo Ossola, ma senz’altro di macchina fotografica. Se non altro per annotare su una scheda di memoria tutto il ben di dio che si è visto da lassù.
Un ’bel‘ panorama
Già Martin Conway e W.A.B. Coolidge, che nella loro guida Lepontine Alps non avevano speso una parola più del necessario sul Basodino, per il Blinnenhorn si lasciarono andare: «This peak commands one of the most splendid views in the district». Una delle più splendide vedute, giusto. E il Blinnenhorn stesso è una «most splendid» montagna quando la si osserva dall’Alto Vallese, col suo bel ghiacciaio che un tempo scendeva fino al lago del Gries. Un lago, prima ancora della sua trasformazione nel bacino artificiale dei nostri giorni, che molti paragonarono per bellezza e ambiente al Marjelensee affacciato sul Grosser Aletschgletscher. Per dire della grandiosità dell’ambiente. Un luogo che può incantare anche chi non l’ha ancora visto, se è vero ciò che scrisse Marcel Kurz (nume tutelare dello scialpinismo) del giorno in cui incontrò un amico che portava con sé una carta topografica bell’e nuova, sulla quale era indicata una cima di cui leggeva per la prima volta il nome, «Blindenhorn»: «Ancora adesso la mia retina è impressionata dalle azzurre curve del ghiacciaio di Gries» (Alpinismo invernale, 1925). E infatti vi salì, dalla Val Bedretto, via Passo Corno, nel febbraio 1911. «Quanto videro i nostri occhi durante questa gita non è ancora scomparso dalla mia memoria». Della cima: «La vista immensa, d’una purezza ammirevole, ci provocò un momento d’entusiasmo, seguito da una lunga estasi». Con tutto che Kurz ne aveva già viste di montagne, e che montagne…
Colpo di fulmine
Adesso: lo so che forse non è uno scritto sulla montagna il posto in cui parlarne, ma scrivendo questa cosa del Blinnenhorn, della possibilità di restare incantati da un luogo prima ancora di averlo visto, ho pensato che lo stesso può accadere nella vita: come innamorarsi di una donna di cui si conosce soltanto il nome che canta un bravo autore; o di una voce, alla quale solo più tardi si assocerà un volto. A me è successo una sera d’agosto, sul tardi. Ero solo in ufficio; la redazione sguarnita nell’ora in cui di solito «chiudevo» la pagina con le ultime dal mondo. Dalla finestra aperta per fare entrare un po’ di fresco, arrivava la voce di Fiorella Mannoia che teneva un concerto in una piazza poco distante. Ed erano cieli d’Irlanda e treni a vapore («di dolore in dolore, il dolore passerà») che venivano e se ne andavano come una brezza leggera e sognante. E io con loro. Poi non sono andato a vedere se Fiorella Mannoia è bella o no. Ma se fosse stata una montagna l’avrei fatto. Volevo dire questo. E in effetti, molti, ma molti anni prima eravamo saliti a vedere com’era questa montagna che ci aveva fatto sentire la sua voce in alcuni racconti narrati da quelli più grandi di noi: «La cima più elevata tra il Monte Leone e l’Adula». Ma non l’avevamo neppure vista, immersa com’era in un nebbione gelido, che si era in agosto ma a noi sembrava un inverno polare.
«Ostia che frecc»
Eravamo un po’ dispersi sulla Gran Sella del Gries e c’era insieme a noi un poeta, sconosciuto ai più, con la barba imbiancata di cristalli, e le poche parole di cui disponeva esitavano sulla soglia della sua bocca sdentata, prima di ricadere senza significato e senza formare versi, stecchite dal freddo. Cercò di comporre un poema, ma si fermò al primo verso: «Quelle otto persone…». Del resto tutte le sue poesie si esaurivano nello stesso modo. L’ispirazione l’avrebbe anche avuta, ma tutto il resto no. Si chiamava Osvaldo, Osvaldese per gli amici e per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare, ma gli ho voluto bene. Poi, uno della compagnia (eravamo in otto, appunto) aveva detto: Ostia che frecc. E don Pietro, la nostra guida, l’aveva inteso come il segnale che era il momento di tornare sui nostri passi, prima che a riscaldarci fossero le fiamme dell’Inferno.
Senza parole
Quando infine la rividi, più e più volte, questa montagna ormai calva per le ragioni che tutti sappiamo, salita da un versante o dall’altro, immiserita di neve sul versante formazzino privo di nome e sempre più rosso di detriti, ecco, quando lo feci conoscevo molte più canzoni e un po’ l’incanto era svanito. No, non svanito, solo messo al sicuro per ritrovarlo la volta successiva. Con Kurz, di nuovo: «Voltandoci indietro sul colle, scoprimmo un’ultima visione: illuminata di ocra dal sole morente, la cima del Blindenhorn lasciava cadere la sua lunga sciarpa bianca marmoreggiata di ombre». E noi che torniamo a salirla, pur se la vediamo quasi sempre e soltanto di spalle, o ne sentiamo la voce serale attraverso una finestra aperta, fidandoci dei libri e della memoria altrui (ché della nostra non fa conto parlare, delle cordate da oratorio, il prete in testa e altri dieci sulla stessa corda, cose da suicidio di messa. Pardon, di massa). Per trovarvi in cima qualcosa di cui scrivere, a ben guardare, è probabilmente superfluo.