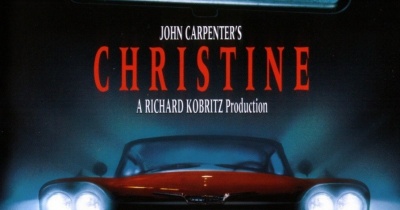‘… e alla batteria, Sheldon Suter’

Figlio d‘arte, quando era ragazzo si “vergognava” di ascoltare e suonare ’il jazz’. Allora punta sulla chitarra… ma bacchette, cassa e rullante non si sono dimenticati di lui
Di Beppe Donadio
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato del sabato a laRegione
Riceve le prime lezioni di batteria dal padre. Inizialmente attivo come batterista soprattutto nel jazz moderno di matrice tradizionale, dal 1997 al 1998 soggiorna a Parigi, dove fa parte del trio di R. Rose e del quartetto di L. Geniez; nel 1999 fonda il trio Collapse e in seguito alla collaborazione con la danzatrice di butoh Flavia Ghisalberti si dedica alla ricerca di un proprio repertorio di suoni percussivi indeterminati. Nel 2009 partecipa al tour ‘Swiss Diagonales’ con il trio Red Note di Max Pizio. Dal 2005 al 2007 è responsabile della programmazione di JazzInFabbrica a Losone; tra il 2010 e il 2014 fa un’escursione nel pop come batterista dei Moes Anthill del singer-songwriter Moe der Barde. Oltre a molte collaborazioni, Suter è leader del trio filo-bebop Sheldon’s Playhouse, co-leader del quartetto Big Bold Back Bone e del duo LostSocks. Le sue musiche sono inoltre utilizzate per sonorizzazioni cinematografiche.
Una batteria semplice, un set essenziale: un piatto solo, rullante, tom, floor tom, cassa e charleston di una preziosa Giannini, costruttore zurighese che in pochi, in passato, si sono potuti permettere. È sempre rimasta montata, anche quando il padre Hugo, batterista di professione fino alla fine degli anni Sessanta, ha fatto famiglia e cambiato mestiere. Quella Giannini adesso è di Sheldon Suter, classe 1971, apprezzato sideman del jazz, undici album incisi dal 2011 a oggi, tanta musica, tanta fotografia, due figlie, un mulino e almeno un tentativo di fare il giro del mondo. “Mio nonno – ci racconta seduto a un bar per le vie della Capitale – lo voleva chirurgo e mio padre invece andò contro tutti, scegliendo la musica”. Fu il bisnonno a pagargli la Giannini di nascosto; un mese dopo, Hugo Suter lavorava nelle orchestre da ballo, così splendidamente jazz negli anni Cinquanta, in Svizzera tedesca, in Francia, Germania, con ingaggi mensili nei kursaal e nei Grand Hotel. “Di quei giorni, quando era ancora vivo, mi ha raccontato cose decisamente avventurose”.
Sheldon viene da Sheldon Manne (1920-1984, più noto come Shelly), star delle orchestre di Stan Kenton e Woody Herman, star del jazz della West Coast, il cosiddetto cool jazz, “quello che mio padre preferiva quando in Europa giravano cose più ‘nere’, più ‘hot’ che venivano da New York”. Tanti i dischi di Manne in casa Suter, che il piccolo Sheldon ascoltava in cuffia: “I quattro volumi di At The Black Hawk, i live registrati nel club in cui Manne suonava. I volumi sono cinque, mio padre ne aveva solo quattro. Li ho ancora: tanto li abbiamo ascoltati, tra me e lui, che li abbiamo ridotti a brandelli”.

© Giuditta Schera
Fotografia musicale
La pubertà, come da enciclopedia medica, porta scompiglio negli ascolti di Sheldon, che rinnega il jazz per Bob Dylan: “Mi sono comperato una chitarra, ma c’entravano anche le ragazze: mi vergognavo un po’ quando, verso i 13-14 anni, mi chiedevano che musica ascoltassi, a rispondere ‘il jazz’. Poi a 16 anni ho capito che suonavo meglio la batteria della chitarra, che il jazz era molto più ricco e che non dovevo farmene più un complesso del fatto che fossi rosso di capelli, svizzero-tedesco, e che mi piacessero le cose di nicchia”. Tendenza che col tempo è diventata caratteristica. L’apprendistato di fotografo invece che una scuola di musica – “Non me la sono sentita di andare via. Sono nato ad Arcegno, già avevo troppa paura di andare a Locarno…” – e la gioventù tra Basilea, da un amico del padre cercando lavoro nella fotografia, e Berna, alla scuola di jazz. Fino a che la fotografia non lo ha portato a Zurigo, “perché nella vita bisogna anche guadagnarsi un salario”.
Musica e fotografia, binario parallelo che ha trasportato Sheldon dal Ticino all’Europa e viceversa per un numero infinito di volte: “A Zurigo mi presi un localino, tre piani sotto un palazzo di assicurazioni, dove suonavo con Christoph Erb, lucernese che oggi suona molto con gente di Chicago”; a Parigi, invece, “uno scantinato umidissimo di quattro metri quadrati ma con bellissime volte antiche” e “tante jam session, in particolare allo Studio des Islettes, frequentato da Archie Shepp a Sonny Murray, che ho avuto il piacere di conoscere”. Il va e vieni dal Ticino, a un certo punto, è diventato soprattutto un va: “Ho deciso di fare il giro del mondo, ma alla prima tappa, in un bar di Basilea, ho incontrato una donna; volevo andare in Russia, sono arrivato fino in Bulgaria e sono tornato indietro, per amore”. Con la danzatrice Flavia Ghisalberti, poi, in duo o con l’aggiunta del trombettista amico d’infanzia basilese Marco von Orelli, è nato il progetto di danza butoh che per Suter corrisponde all’inizio di una profonda revisione sonora sottrattiva giunta sino agli odierni ‘Nocturne’ per sola batteria: “Oggi, il mio non è nemmeno più un set di batteria classico. Ricerco suoni lunghi su di uno strumento che di suo ha suoni corti, ritmici, fatta eccezione per il sustain che possono avere una cassa o i piatti”. E quindi “gong, scodelle tibetane, e altri elementi che vanno oltre le bacchette, le spazzole o i mallet, in nome dell’improvvisazione libera europea arrivata alla fine degli anni Sessanta”. Un set minimo e pratico per questioni di peso, “ma anche un minimo dal quale tirare fuori il massimo”.

© Giuditta Schera
Glauser e il ritorno
Come un solo che parte in levare, a un certo punto della storia entra in scena un mulino. “Il mulino del Brumo, ad Arcegno, è il luogo ideale per potersi ritirare nella propria solitudine e nella natura, dare tempo al vissuto di fermentare e poterne poi distillare dei contenuti sensati, delle conoscenze, del materiale. Apparteneva a una signora inglese, che mi diede il permesso di abitarlo. È il mulino in mezzo al bosco in cui nel 1919 visse anche Friedrich Glauser, ci sono bozze di suoi polizieschi che ne parlano. Un posto un po’ magico che alla fine sono riuscito a comperarmi”. Il mulino del Brumo è anche il posto migliore “per leccarsi le ferite, dedicandosi al giardino, passeggiando per i boschi, per un anno”, fino all’incontro con Giuditta; il mulino è anche il punto d’approdo di cotanto peregrinare: “Ho sempre dato priorità al ‘fare esperienza di vita’ più che a motivi prettamente professionali o di ‘carriera’. Per me, la sorgente da cui può attingere l’arte è la vita stessa, il proprio vissuto. Per questo ho sempre considerato importante viaggiare, confrontarmi con luoghi nuovi e poter incontrare persone diverse”. Esperienze di vita che fanno di Sheldon, parole sue, “non certo un purosangue, piuttosto un bastardo che invece di dare priorità totale alla fotografia o al fare musica ha sempre preferito, semplicemente, vivere”.
Tornato, più adulto, a Zurigo – “Una scena molto viva dieci anni fa, tantissime jam anche durante il giorno. Lì ho studiato tanto e ho registrato molti degli undici dischi” – e transitato un’ultima volta da Basilea, Sheldon Suter, due volte padre, ha infine scelto il Ticino come luogo in cui vivere e far crescere le sue bimbe insieme a Giuditta, due volte madre, in una serena riappacificazione con Locarno, la città. Che a uno nato ad Arcegno e che ha tentato di fare il giro del mondo, oggi, non fa più paura.

© Giuditta Schera