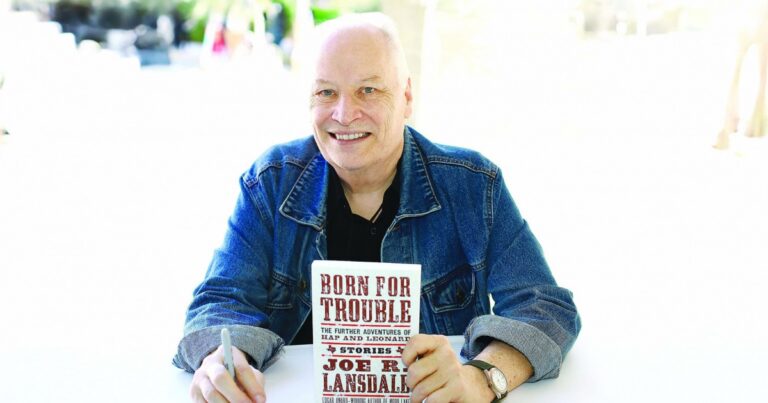Così facciam tutti

La definizione di ‘conformismo’ è laconica, ma la questione va ben oltre: si tratta di omologazione (spesso inconscia) dettata dal bisogno di accettazione
Di Giovanni Luise
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione
‘Tendenza a conformarsi, anche solo in apparenza a dottrine, usi, opinioni prevalenti socialmente e politicamente’. Questa è la laconica definizione del concetto di conformismo che si legge nel vocabolario. Ma la questione va ben oltre le parole: si tratta di un processo sociale per cui adattiamo il nostro comportamento (insieme a pensieri e atteggiamenti) a quello della maggioranza o del gruppo di appartenenza. Questa omologazione, spesso inconscia, è dettata dal nostro bisogno di accettazione.
“Allora se gli altri si buttano giù dal ponte che fai? Ti butti anche tu?”. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo pronunciato la celeberrima frase cercando di convincere il nostro interlocutore a non subire l’influenza degli altri. Tutti con scarsi risultati, ovviamente.
Adattamento sociale
Le ricerche rivelano che si aggira intorno ai 3 anni e mezzo l’età in cui cominciamo a seguire le regole della morale comune, mettendo in atto comportamenti finalizzati più all’adattamento al gruppo che al rispetto delle regole di mamma e papà. L’exploit avviene in fase adolescenziale quando di colpo si smette di compiere le scelte con la propria testa e ci si affida alla “comitiva” , che incarna quel modello fonte di ispirazione nella costruzione dell’identità di ciascun giovane diventando il “sostituto genitoriale” per eccellenza a cui obbedire e conformarsi. Con grandissima soddisfazione dei genitori, ovviamente.
E si finisce da adulti, quando travolti dalla necessità di sopravvivenza nella quotidiana giungla collettiva, l’uomo tenta di trovare conforto e ristoro in quell’adattamento sociale capace di farlo sentire più adeguato (o comunque un po’ meno inadeguato) rispetto ai contesti lavorativi e personali. La psicologia sociale ha tra i suoi scopi quello di studiare le interazioni tra l’individuo e un determinato gruppo misurando il grado di influenza derivante dalla presenza di altre persone, e in questo processo di misurazione l’elemento più attenzionato è… la quantità.
Una questione di misura
Perché come qualsiasi (buon) manuale di introduzione alla psicologia dovrebbe insegnare, ciò che distingue la normalità dalla patologia… è sempre la quantità. Il tema, quindi, non è se ci facciamo influenzare, bensì è quanto quest’influenza interferisce sull’autonomia delle nostre scelte. È possibile abbandonare le proprie idee perché fuorviati dal gruppo? È giusto tendere all’omologazione della maggioranza?
L’esperimento
Negli anni Cinquanta lo psicologo polacco Solomon Asch esaminò il fenomeno della conformità attraverso un esperimento in cui venivano mostrati tre segmenti di diversa lunghezza a dei partecipanti a cui era affidato il compito di indicare quale fosse quello uguale a un segmento standard. Sperimentazione banale? No, poiché tutti i componenti del gruppo erano complici di Asch addestrati a fornire la medesima risposta sbagliata. Tutti, tranne colui che rappresentava il vero oggetto di studio. I risultati, ripetuti più volte con i singoli soggetti ignari del tranello, furono clamorosi. Quasi l’80 per cento aveva negato le proprie percezioni indicando le linee sbagliate nonostante l’evidenza lampante davanti agli occhi e malgrado le risposte assurde e palesemente errate degli altri; il partecipante “reale” si era adeguato e conformato al gruppo al punto da rinunciare alla sua personale opinione dando così prova dell’enorme potere del conformismo e dell’influenza sociale.

© Wikipedia
Solomon Asch
La verità è che ci piace essere accettati. Anzi, ci fa sentire protetti e compresi. Che poi, a pensarci, non sono proprio le (rare) persone che riescono a comprenderci per davvero quelle che amiamo?
Il gruppo può indubbiamente rappresentare un’occasione di apprendimento o un’esperienza di conoscenza e rimane un mezzo interessantissimo per colmare le proprie lacune, ma occorre prestare attenzione alla giusta dose. Il mondo è sommerso di reati che trovano la propria radice generativa in un’identità di gruppo conformistica: bullismo, violenza da branco, cyberbullismo, femminicidio, scontri tra ultras ecc. In tutti questi casi è proprio la volontà di non contrastare la maggioranza a consentire la perpetrazione di una condotta che il singolo probabilmente non avrebbe mai commesso, e che forse nemmeno condivide, ma che all’interno di quel contesto non appare così terribile. Insomma, molti di noi hanno la percezione (oltre alla presunzione) di essere speciali, di non essere affatto inclini a seguire le mode e di non farsi troppo condizionare.
Io sono uno di quelli.
Io mi sento unico.
Eppure, se mi fermo un attimo a guardare i miei vestiti, le mie scarpe, il mio orologio, il mio cellulare, i posti che frequento e le decine di scelte che compio ogni giorno, mi rendo conto che sussiste un’apparente assenza di motivi in tutto ciò, ma al contempo percepisco una sorta di “gratificazione sociale” probabilmente figlia di una pulsione narcisistica presente forse in ciascuno di noi.
Dovremmo domandarcelo più spesso: quanto siamo disposti a perdere della nostra unicità per diventare, alla fine, come tutti gli altri?