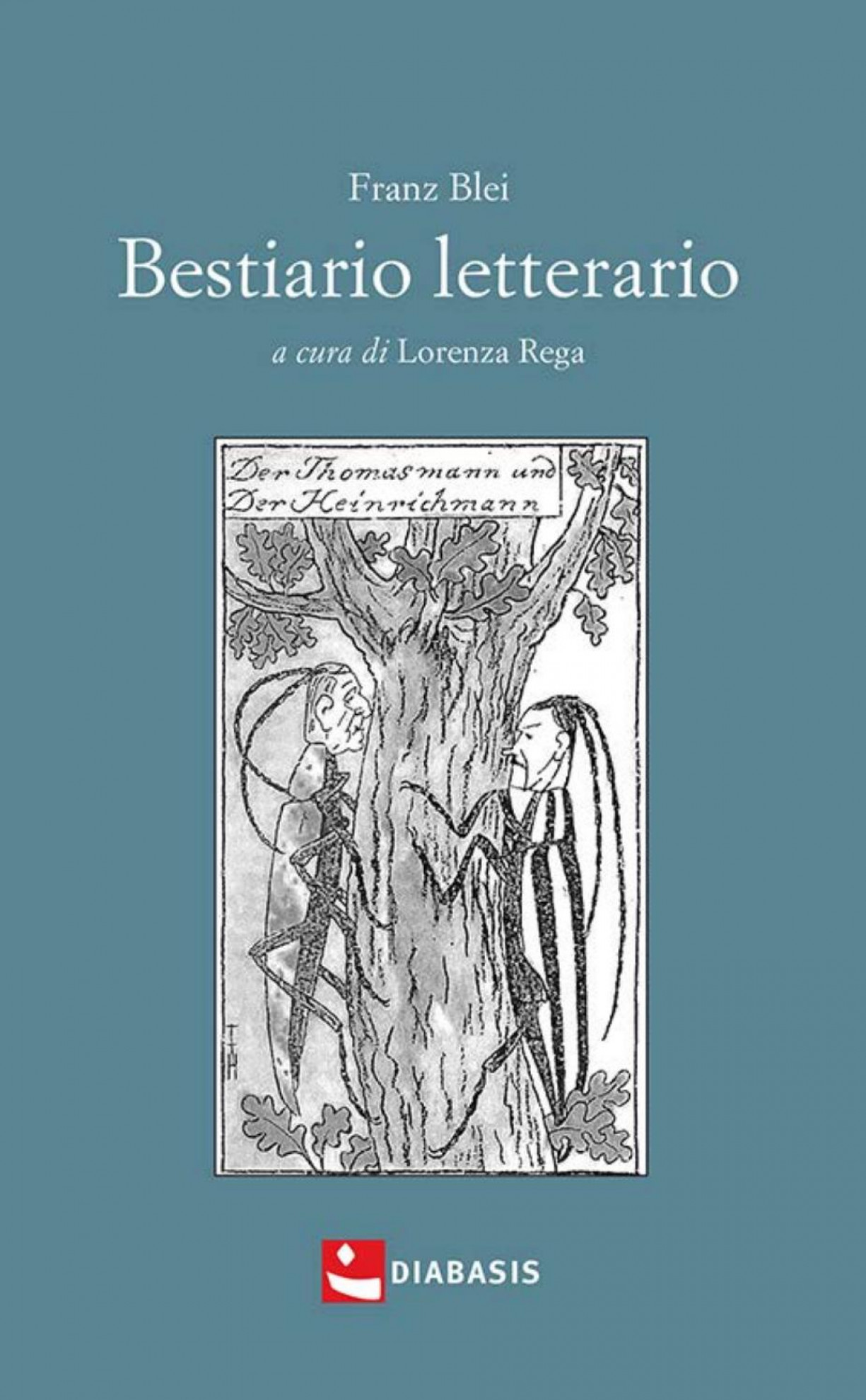Le amare profezie culturali di Luciano Bianciardi

“Parrà strano, ma nel mondo delle lettere il peggior peccato di uno scrittore consiste nello scrivere”
Di Valerio Rosa
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione
Milano, metà anni Cinquanta. Luciano Bianciardi vi si è trasferito da qualche mese, ma è già irrimediabile il suo senso di estraneità ai ritmi e alle nevrosi di una metropoli che, nell’umile alba di ogni nuovo giorno, è solo periferia e pioggia e incessante operosità. Come Giorgio Gaber alcuni anni dopo, avverte quanto sia alienante e frustrante, per un idealista impreparato ad affrontare la vita, allinearsi alle rotelle dell’ingranaggio che organizza la nascente società consumistica, integrandosi nella città “piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le réclames sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più”.

Nella città del rampante capitalismo italiano, Luciano Bianciardi è stato chiamato a partecipare alla creazione di una nuova casa editrice, la Feltrinelli, che più tardi, parodiando il tonitruante trionfalismo della retorica comunista, definirà “la grossa iniziativa”. Lo stipendio è insoddisfacente, gli permette pasti miseri non più di una volta al giorno e, tolte le spese per l’affitto, le tasse e qualche acquisto a rate, gli lascia pochi spiccioli per
i vestiti, costringendolo a girare con un cappotto liso, rivoltato centinaia di volte. A una riunione serale si presenta Giangiacomo, il fondatore, che con i libri si propone l’umile obiettivo di cambiare il mondo e combattere le ingiustizie: appoggiato il cappotto di cammello accanto a quello consunto di Bianciardi, attacca un mortifero e interminabile sermone sulle diseguaglianze e l’equità sociale. Sfinito, Bianciardi ha un’alzata d’ingegno per la quale ogni città civile dovrebbe intitolargli ospedali, scuole, piazze, case, vicoli e palazzi: alzandosi mentre il padrone sta ancora parlando, ne indossa il prezioso soprabito, si pavoneggia come una mannequin e, col pugno alzato, proclama: “Viva la lotta di classe!”. E poi se la svigna. Questo quindici anni prima che altri due personaggi spiantati, decadenti e disillusi, Paul-Marlon Brando ne L’ultimo tango a Parigi e Daniele Dominici-Alain Delon ne La prima notte di quiete, rendano il cappotto di cammello, abitualmente diffuso nell’alta borghesia, un’icona di maledettismo e disincanto.
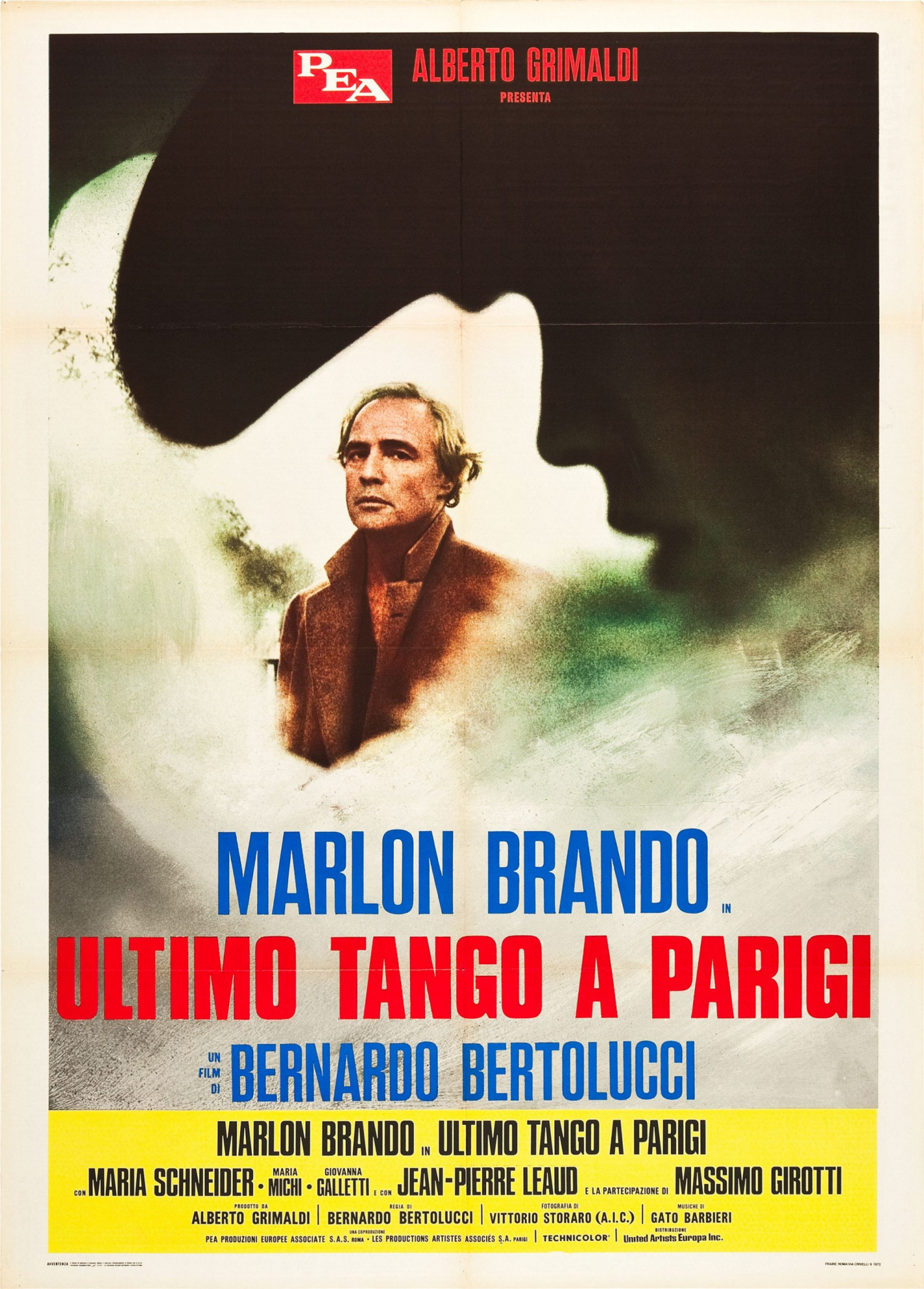


Sulle formule vuote e i tic lessicali della fauna intellettuale Bianciardi riverserà tutta la sua velenosa ironia. Uno strepitoso capitolo de Il lavoro culturale affronta il problema del linguaggio, che, in quanto problema, “nonostante la differenza spaziale (alto-basso) dei due verbi, si pone o si solleva“, per poi aprirvi un dibattito, che sarà ampio e approfondito, e infine un’analisi, la cui giustezza verrà confermata dagli avvenimenti. Al dibattito gli interventi portano un utile contributo. Dal dibattito scaturiscono o emergono alcune indicazioni. E non mancherà, al momento opportuno, tutta una serie di iniziative nella misura in cui e sul terreno del. Questo è solo un frasario essenziale, la registrazione di un gergo, ma per garantirsi un’onorata carriera e addirittura prosperare “in quel campo di attività umane, non essenziali peraltro alla vita dell’uomo, che vanno sotto il nome complessivo e vago di cultura”, serve un manuale come si deve, che prenda atto della degradazione del libro a oggetto di consumo, a prodotto da supermercato, a una merce non dissimile dal cibo in scatola acquistato da uomini e donne con gli occhi arsi dalla febbre del comprare. E la conseguenza è quella diagnosticata da Ennio Flaiano: “La disattenzione è il modo più diffuso di leggere un libro, ma la maggior parte dei libri oggi non sono soltanto letti ma scritti con disattenzione. Oppure con un’attenzione che fa parte dell’intesa autore-lettore. Si legge come si fuma, per tenere occupate le mani e gli occhi”. Da questa premessa Bianciardi si scatena con sei interventi pubblicati nel 1966 sul settimanale italiano ABC e raccolti da Neri Pozza in Non leggete i libri, fateveli raccontare (2022): lezioni per salvare giovani privi di talento da una mediocre esistenza da impiegati di banca, controllori delle ferrovie e impiegati del catasto.

La ‘cultura’ logora
Un Bianciardi amaro, disgustato da una produzione editoriale sovrabbondante e superflua, che rende inutili lo studio, l’approfondimento e naturalmente la lettura stessa: un vero intellettuale lascerà che gli altri si informino e si aggiornino per lui, perché la sola cosa che conta è come fare carriera, sapendo cosa dire, come porsi, come vendersi, come arruffianarsi i superiori e neutralizzare i concorrenti, marcando gli uni a uomo e gli altri a zona, senza trascurare l’importanza strategica di una segretaria complice e di una moglie che sappia muoversi nei salotti culturali. Non ci stupiremmo se in qualche corso di formazione aziendale si prendesse sul serio questo vademecum del successo, che in realtà è il testamento in anticipo di un uomo esasperato, che a mezzo secolo dalla morte continua a guardarci, come in tutte le foto che lo ritraggono, con occhi spaventati, con la sua incapacità di essere felice e il suo ostinato teppismo intellettuale, e continua a chiederci comprensione e amicizia, commuovendoci mentre ci colpisce allo stomaco. Se Franz Blei avesse letto Bianciardi, probabilmente nel suo Bestiario della letteratura lo avrebbe affratellato a Huysmans: “È una specie di salamandra. Non è bruciato neppure nel fuoco dell’inferno in cui era precipitato: continua invece a bruciare e a risplendere come il diavolo nella cella di una monaca”.