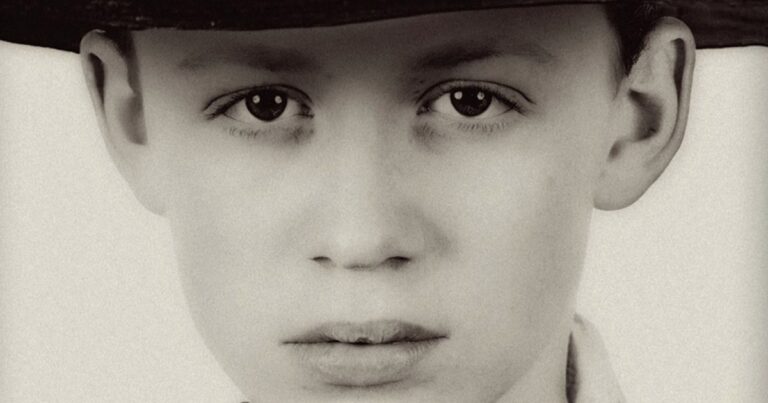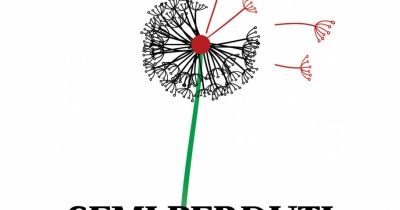Pizzo Cornera. Toccare la cima, ma con molta attenzione

” (…) il pietrone che ne costituisce la vetta balla da far spavento, come ci eravamo resi conto con un brivido io e il Maurino, quando l’avevo salito.
Di Erminio Ferrari
Pubblichiamo un contributo apparso in Ticino7, allegato del sabato a laRegione.
Molti anni dopo, l’Alberto mi ha chiesto perché mai ci fossi salito. Non ho saputo dargli una risposta convincente, mi sembra. Non saprei però rispondere plausibilmente neppure a chi mi chiedesse perché vado in montagna, a parte uno scontato “mi piace”.
Ma la domanda dell’Alberto, che di montagne ne ha salite quante io posso solo sognare, non era peregrina: visto dalla cresta della Punta Devero, dove ci trovavamo allora, il Pizzo Cornera è tutto fuorché invitante. ’Sto ammasso di pietre instabili, al cui vertice si innalza un torrione claudicante: il pietrone che ne costituisce la vetta balla da far spavento, come ci eravamo resi conto con un brivido io e il Maurino, quando l’avevo salito una prima volta. Molti anni addietro appunto. Il Maurino col solito cappellino da ciclista di una volta, portato con l’aletta girata indietro, si sappia.
È che il Pizzo Cornera (Gischihorn per i vallesani, che sì amano l’Alpe Devero, ma da quel coso si tengono alla larga) ha tante facce. Quella che si intuisce da Devero e che domina la Val Buscagna ha incantato e attratto gli scalatori fino dall’età aurea dell’arrampicata in Devero. Al Tino Micotti si lustravano gli occhi quando mi raccontava delle sue corse anni Sessanta alla base di quei pilastri, quei crestoni, per trovarvi lo stesso stupefacente piacere che Bonatti trovava sul granito del Bianco. E dopo di lui era venuta la generazione dell’Alberto (Paleari), dei Montani, e poi i Pe, Rossi, Masciaga e tutti gli altri, fino alle vie più moderne sul “Triangolo” (ché non ce l’ha mica solo il Tacul il suo Triangle).
Difficile e ‘vertiginosa’
L’altra faccia del Cornera fu terreno di scoperta e di azione per gli alpinisti dell’Ottocento, o per quelli pur nati dopo ma che sono arrivati in ritardo. Il reverendo W.A.B. Coolidge, anch’egli “principalissimo esploratore delle Lepontine […] sempre accompagnato dal suo fidato Cristian Almer jun.” (scrisse Riccardo Gerla), lo osservò, nel 1886, dalla cima del Cervandone, del quale aveva fatto la prima salita turistica. E gli fece una tale buona impressione che sei anni dopo decise di tentarlo. Era gente con un sacco di tempo a disposizione; ereditieri, o professori che passavano le estati a girare per le montagne, e quella del 1892 fu quella buona per il Gischihorn (anche lui lo chiamava così). Partirono da Binn e non si fecero intimorire dall’aspetto “très rebarbatif et assez difficile” della montagna. Arrivarono al valico che oggi si chiama Passo del Cervandone, ma che lui più correttamente avrebbe chiamato Guschijoch, e si innalzarono fino alla torre sommitale.
Con una scalata “quelque peu difficile, et pendant la dernière partie assez vertigineuse” arrivarono in vetta. Vi innalzarono, scrisse Coolidge, una “piccola piramide”, un ometto.
Su, ma senza ragione
Me lo vedo ancora, il Maurino, centosedici anni dopo, saldo su quella cima instabile. Saldo nelle sue convinzioni, intendo. E io che scatto qualche foto e gli faccio: è meglio scendere, adesso. Tanto che ci siamo rimasti meno dei 18 minuti riportati da Coolidge (uno pesante, che annotava tutto).
Al ritorno abbiamo ripercorso all’inverso la salita del reverendo (che saggiamente indicava la possibilità di tornare a valle sul versante di Devero), abbassandoci su quella frana immensa che è il fianco vallesano, uscendo poi al Passo di Cornera, quindi dal bivacco Combi e Lanza giù di nuovo in Val Buscagna. Alla locanda Fattorini, tra una birra e l’altra, l’abbiamo poi raccontato al Dino Vanini. Lui ci ascoltava sorridendo dalla sua barba bianca, con la benevolenza sincera del montanaro che ne sapeva abbastanza per non prendere in giro le nostre ingenuità alpinistiche.
Perché ci eravamo saliti, Alberto? E chi lo sa. Il fatto è che qualche anno più tardi ci sono poi tornato con l’Angelo. Stessa strada, stessa osteria. In cima, il solito sassone traballante sembrava ancora più instabile. E non c’era stato neppure il modo di scattare una foto, per via di una gran nebbia che ci aveva avvolti in pochi minuti. Sotto la vetta c’era uno spezzone di corda annodato attorno a una delle poche rocce salde di tutta la montagna. Ci ho aggiunto una fettuccia e con una calata approssimativa, e oltretutto con la corda troppo corta per arrivare a posare i piedi su qualcosa che tenesse, abbiamo lasciato quel posto senza rimpianti. E dall’espressione dell’Angelo capivo che era meglio così.

© E. Ferrari
‘Like a rolling stone…ʼ
Quando poi ci siamo avventurati sul pendio che dal valico cala sulla Svizzera (“si può – avevo garantito – l’altra volta sono sceso col Maurino”), due massi grandi come frigoriferi si sono staccati dalla montagna, inseguendoci senza misericordia.
Il bastone che porto sempre con me mi è stato strappato di mano da uno dei due bolidi. L’ho ritrovato, smorto come uno straccio, ma illeso, cento metri più in basso. Non che io avessi più colore. Quello, il colore, lo abbiamo poi ripreso solo quando abbiamo posato i piedi di nuovo nel vallone che risale al Passo di Cornera.
La nebbia si era diradata, quella nebbia, mi raccontavano i vecchi contrabbandieri, che era meglio non incontrare mai al Cornera, quando vi salivano carichi di sigarette da Heligkreuz. Poi in Devero, via Buscagna. Il Tonino, un’anima del Devero, se i luoghi hanno un’anima (e se lo chiedeva già Camus) era come se ci aspettasse. Lui, i suoi molti anni e il suo grande cuore. Ci siamo seduti a bere una birra, e gliel’abbiamo raccontata.
E anche lui sorrideva.