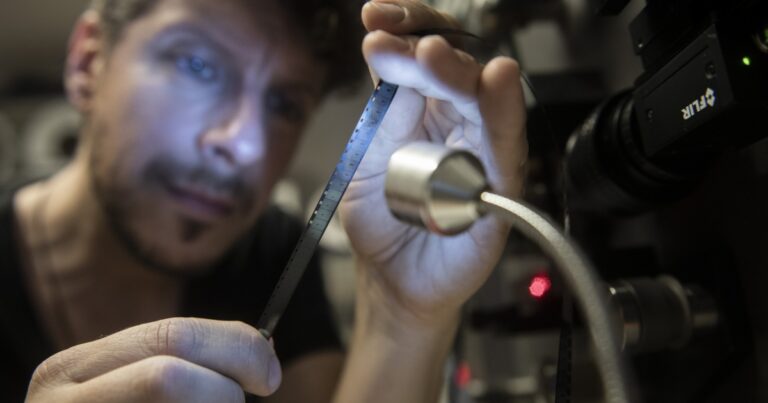Macerie d’Albania: storie da un paese che vuole crescere

Lo scorso maggio il Teatro nazionale di Tirana è stato raso al suolo, nonostante una forte opposizione popolare.
Di Cristina Pinho
Pubblichiamo un contributo apparso in Ticino7, allegato del sabato a laRegione.
“Ciò che non ha fatto il terremoto lo ha fatto lo Stato” è una frase che in albanese ha il suono pertinente e beffardo di una rima infelice: “S’e bëri tërmeti e bëri Pushteti”. La troviamo al centro di una canzone composta da Marco Zappa a seguito dell’abbattimento del Teatro nazionale di Tirana avvenuto il 17 maggio scorso, in piena notte e in piena emergenza sanitaria. Le immagini delle ruspe in azione e le macerie rimaste in seguito al crollo hanno fatto il giro del mondo mostrando il vuoto lasciato nel cuore della capitale assieme allo sconforto e all’umiliazione di coloro che hanno lottato fino all’ultimo per un epilogo diverso. Nei filmati si vedono in strada decine di agenti di polizia che disperdono artisti e simpatizzanti con maniere brusche e spray urticanti, conducendone altri fuori dall’edificio in manette e in lacrime, come il fratello di Elvira Dones. “Ero al telefono con lui fino a poco prima, poi hanno interrotto il segnale per impedirgli di comunicare. Ho saputo quello che è successo dopo dai video; in vita mia lo avevo visto piangere solo per la morte di nostro padre; lo conosco, non lo faceva per lui, ma per i suoi figli, per l’Albania”, racconta a distanza di giorni ancora amareggiata. Elvira Dones è nata a Durazzo, città portuale duramente colpita dal terremoto del novembre scorso, e uno dei principali luoghi da cui dal 1991 centinaia di migliaia di albanesi sono salpati da un deserto di possibilità verso le coste pugliesi, con la speranza di trovare in Occidente la libertà a lungo sognata. Nel Paese balcanico si aprivano allora le maglie di quei confini dentro cui erano stati segregati i suoi abitanti per 45 anni, dal governo di stampo stalinista di Enver Hoxha e del suo successore Ramiz Alia. La fuga di Elvira è avvenuta 3 anni prima della caduta del regime, con approdo in Ticino dove risiede tuttora; di professione scrittrice e documentarista, ha spesso raccontato della sua terra di origine e dei dolori del suo popolo. Con lei e suo marito Vasco Dones, giornalista svizzero e pure lui documentarista, parliamo della vicenda del Teatri Kombëtar e di cosa questa ci rivela dell’Albania odierna.
Oltre l’edificio
“Erano due edifici gemelli costruiti dagli italiani nel ’39 che sembravano usciti da una delle piazze metafisiche di De Chirico, testimonianza della storia del Paese nel bene e nel male – dice Vasco –. C’erano sicuramente dei problemi da risolvere per cui si chiedeva un intervento di ristrutturazione, ma il governo ha deciso per l’abbattimento e la costruzione di un teatro moderno integrato in un grande complesso residenziale e commerciale, con la formula del partenariato pubblico-privato, il tutto senza alcun tipo di consultazione trasparente. Così un altro pregiato pezzo di terreno pubblico verrà presumibilmente svenduto per interessi privati”. All’annuncio del progetto si è costituita l’Alleanza per la difesa del teatro, un gruppo apartitico eterogeneo ma molto unito che per 27 mesi, fino all’ultimo atto, ha presidiato, occupato e animato il luogo con continui spettacoli, incontri e dibattiti. La questione va dunque ben oltre l’edificio: “Era un simbolo culturale e sociale, uno spazio di fermento, dove si generavano idee, diversi modi di stare assieme e anche di pensare la politica”, spiega Elvira.

Spina dorsale da costruire
Ripercorrendo quella che Vasco definisce “una parabola iniziata nella speranza e finita nella vergogna”, le parole che emergono sono speculazione edilizia, corruzione, associazione a delinquere, oligarchia del cemento, narcotraffico, compravendita di voti. Questioni con cui oggi l’Albania si trova confrontata, connivente la politica. “Per questo abbiamo la completa sfiducia in tutti i partiti, che sia quello al governo o i due all’opposizione. L’idea diffusa tra la gente è che sono tutti uguali e che poco cambierà qualsiasi sia il risultato delle elezioni del prossimo anno”. Elvira è concorde: “Il Paese è fragile, non è ancora riuscito a farsi una spina dorsale; per la sua posizione geografica ha sempre subito invasioni e vessazioni: 5 secoli di Impero romano, 5 di Impero ottomano, una parvenza di indipendenza, poi l’occupazione fascista e quella nazista”; seguono la liberazione partigiana e un’utopia presto trasformata in un incubo: un passato asfissiante di cui la popolazione patisce ancora le convulse conseguenze. “Negli ultimi 30 anni la nazione ha attraversato tutte le malattie infantili di un Paese post-dittatoriale. Aveva fame di tutto, ma la democrazia è un processo lento da costruire, e ancora adesso non ci siamo, questa è piuttosto una ‘democratura’”, sottolinea Elvira.
Aprire la stanza dei bottoni
“Nel 2013 – riprende –, come molti, avevamo riposto fiducia nell’elezione al governo del Partito socialista del primo ministro, ma ben presto si è capito che di sinistra aveva ben poco”. Un clamoroso passo falso lo aveva fatto quando si era offerto di stoccare e smaltire sul territorio le armi chimiche del conflitto siriano: in quel caso, ricorda Vasco, “la popolazione si oppose con delle proteste e bloccò l’operazione. Si tratta di un evento che assieme alle manifestazioni studentesche dell’inverno del 2018 e alla battaglia dell’Alleanza per il teatro costituisce uno dei pochi momenti in cui qualcuno ha cercato di tener testa al governo. Per questo siamo così attenti alla vicenda del Teatro e al suo seguito”. “Speriamo che le proteste continuino, perché in questo contesto il cambiamento può venire solo dalla società civile – continua Elvira –. Il problema è che oltre a rassegnazione c’è paura, perché chi interferisce con i poteri forti si trova terra bruciata tutto intorno, ad esempio a livello lavorativo, per sé e per i propri familiari”.
Un Paese che si svuota
Restando così le cose, le prospettive per il futuro non sono delle migliori. “È un luogo dove non è facile vivere. L’esodo dall’Albania continua, e a fermare l’emigrazione c’è stato solo il coronavirus. La disperazione economica è grande, la povertà dilagante, mentre al vertice sta la setta di oligarchi che getta a terra le briciole. Il Paese rimane a galla grazie alle rimesse della diaspora e ai traffici illeciti. C’è una fuga di cervelli, i professionisti più qualificati trovano buone condizioni nei Paesi scandinavi o in Germania, ma ad andarsene è anche la gente con meno risorse, e sappiamo come viene accolta”. Chi è partito nonostante tutto ama profondamente il Paese e vi è molto attaccato. “Siamo tutti immigrati di corto corso e abbiamo una cultura clanica che mette la famiglia al primo posto, per cui siamo molto legati alle nostre radici, all’albanesità. Si tratta di un Paese meraviglioso, ricco di paesaggi spettacolari, che spazia dalle Alpi del Nord alle coste sui due mari, con tradizioni variegate frutto di una storia millenaria”. Senza dimenticare la gentilezza e lo spirito ospitale di un popolo che ha molto da raccontare, ora anche di una porzione di identità rasa al suolo e di un’altra generata proprio attraverso la lotta per salvaguardarla.