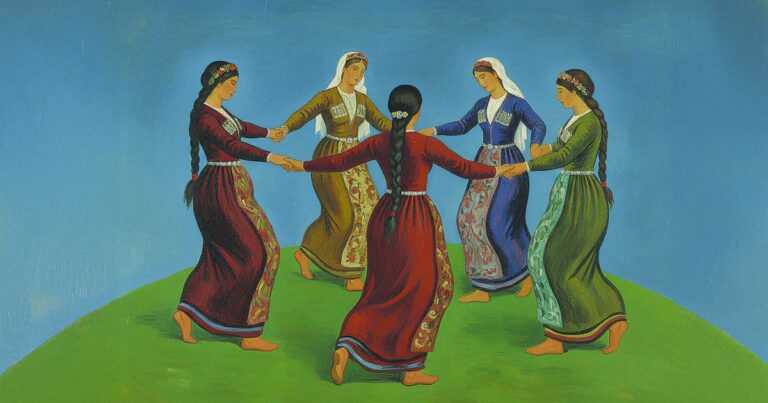Liberismo: il pensiero della porta accanto

Tutto a posto finché i consumi tirano e la gente spende. Se le cose vanno meno bene deve intervenire lo Stato. E chi altri?
Di Generoso Chiaradonna
Il capitalismo, secondo alcuni, sarebbe in crisi da almeno un decennio. Dal 15 settembre 2008, giorno del fallimento della banca d’affari Lehman Brothers, se si vuole dare una data simbolica che segna un prima e un dopo. Quella crisi di sistema poteva essere l’occasione per ripensare in meglio il modo di produzione capitalista basato prevalentemente sulla finanza e quindi su una logica di appropriazione (o rapina) per definizione e non di redistribuzione. Così non fu. Anzi, da allora il capitalismo di stampo ‘neoliberista’ ha preso ancora di più il sopravvento nonostante si parli da più parti di un rallentamento del processo di globalizzazione dei mercati.
Complici le schermaglie tra Cina e Stati Uniti sui dazi commerciali, questo processo starebbe addirittura conoscendo una fase di stallo o di arretramento. Ipotesi in un certo senso avvalorata dalle tendenze protezionistiche in atto in alcuni Paesi occidentali, dove si aggirano gli spettri del ‘sovranismo’ e del ‘populismo’ (come se un concetto reggesse per forza l’altro) che rischiano di riportare indietro di qualche decennio le lancette della storia. Frontiere fisiche e psicologiche, inoltre, stanno per essere nuovamente erette in Europa grazie alla Brexit. Insomma, tutto farebbe pensare di essere in una fase storica dove l’intervento dello Stato in economia stia ritornando agli antichi fasti. Nulla di più falso.
In realtà il neoliberismo non ha mai goduto di così tanto credito – a dir la verità inconscio e ideologico – da parte di comuni cittadini e istituzioni. L’inglese Mark Fisher, pensatore della modernità morto suicida tre anni fa, ha riassunto in modo mirabile questa situazione nel suo saggio Capitalismo realista. Il suo pensiero, in estrema sintesi, è il seguente: le nefaste ideologie del passato (comunismo e nazifascismo) avevano bisogno di un forte apparato di propaganda per far credere ai loro cittadini di vivere nel migliore dei mondi possibili. Oggi sarebbero gli stessi lavoratori, consumatori ed elettori ad autoconvincersi che non ci sia alternativa allo stato di cose in cui si trovano. L’offerta politica, da destra a sinistra con sfumature minime, del resto ha solo questa visione della società da offrire.
Genesi
Nel dibattito pubblico il neoliberismo – o meglio, l’attuazione di politiche economiche derivate da questa corrente di pensiero – è spesso inteso, e a volte a giusta ragione, negativamente. Il principio cardine su cui poggia il liberismo (neo o ‘vetero’ che sia) è che la competizione economica e sociale è l’unico sistema in grado di rendere efficiente l’agire umano. È quindi un mezzo potentissimo per fare ordine, stilare classifiche economiche e sociali, creare vinti e vincitori. E questo in tutti i campi e con un consenso popolare francamente immeritato.
Il mercato, questo luogo astratto e anche un po’ mistico ed esoterico – lasciato libero da vincoli statali –, sarebbe in grado di dare un prezzo ‘equo’ a tutto: alle patate, al corso di laurea, al salario di un operaio e finanche al
bonus – milionario per definizione – dei manager, novelli principi medievali. Non si spiegherebbe altrimenti come sia possibile che la produttività del lavoro sia remunerata mille volte di più al vertice di una società quotata, rispetto all’ultimo dei suoi impiegati. Eppure, secondo questo modo di vedere, il mercato sarebbe in grado di premiare comportamenti virtuosi e punire quelli viziosi. Poveri e disoccupati sarebbero tra i perdenti per colpa loro e non per condizione infausta. Non solo. Secondo questi principi, il mercato sarebbe in grado di rendere efficiente anche la gestione dei servizi pubblici essenziali (scuola, sanità, utilities municipalizzate di acqua, gas, elettricità e gestione dei rifiuti). C’è del vero in ciò, ma come spesso accade il diavolo è nei dettagli. Il controllo democratico su questi ambiti diventa secondario e addirittura ininfluente tanto che si può avere un regime economico liberista (quindi liberale in senso classico) anche dove le libertà fondamentali dell’uomo sono addirittura represse.
Il caso della dittatura cilena tra il 1973 e il 1990 è da questo punto di vista emblematico. O quello cinese, per rimanere ai nostri giorni. Fu proprio nei decenni sanguinari del generale Augusto Pinochet che le teorie neoliberiste di Milton Friedman (l’economista statunitense Premio Nobel e fondatore della cosiddetta scuola di Chicago) ebbero piena applicazione. E i danni sociali, in quel paese e presso gli altri ‘buoni allievi’ sudamericani dei liberisti nordamericani, si contano ancora oggi: uno Stato ridotto ai minimi termini dove servirebbe (istruzione, sanità e sicurezza sociale) e un forte apparato militare e poliziesco rivolto contro i cittadini più deboli.
Tutto nasce a Parigi
Incominciamo con il dire che nel 1938, quando alcune delle teste pensanti e controcorrente dell’epoca si ritrovarono a Parigi – tra questi, per citare i più noti, c’erano gli economisti austriaci Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises – la deriva autoritaria dell’Europa (a Est il comunismo stalinista e a Ovest la barbarie nazifascista) era conclamata tanto che di lì a poco avrebbe causato milioni di morti, distruzione e miseria su larga scala. L’incontro parigino, quindi, mirava a riformare le basi del liberismo economico (il ‘laissez-faire’ ottocentesco, per intenderci) che in quel periodo, per usare un eufemismo, non aveva buona fama. L’opinione comune di allora – non a torto – imputava al liberismo la causa della Grande Depressione del 1929.
Fu proprio durante questo incontro che si coniò per la prima volta la parola neoliberismo, per cercare di identificare un’ideologia che intendeva proporsi quale terza via tra l’assenza quasi totale dell’intervento statale in economia e la pianificazione economica collettivista. Insomma, i neoliberisti delle origini, per usare termini di paragone odierni, erano dei centristi moderati che si ponevano in alternativa alla destra e alla sinistra di allora. Erano certamente intellettuali preparati che avevano molto a cuore la libertà individuale e che consideravano lo Stato – almeno quello che avevano sperimentato sulla propria pelle –
potenzialmente dispotico e prevaricatore. Lo scoppio della Seconda guerra mondiale costrinse i due fondatori della cosiddetta scuola austriaca a emigrare: von Mises negli Stati Uniti, dopo un breve soggiorno in Svizzera, e von Hayek in Gran Bretagna.
Il trentennio glorioso
Archiviata la Seconda guerra mondiale, e diviso il mondo in due blocchi che quasi non comunicavano tra loro, se non in termini di quanti missili nucleari uno avesse puntato sull’altro, l’Occidente – al quale ora appartenevano anche l’Europa ex nazifascista e il Giappone – conobbe un progresso sociale ed economico senza precedenti. Merito certamente della ricostruzione post-bellica, dei tanti miliardi di dollari del piano Marshall piovuti da oltre Atlantico, dell’impostazione keynesiana della politica economica attuata dai governi dell’epoca (intervento pubblico), ma anche di un fenomeno che non era stato sperimentato – non in quella misura, almeno – nei decenni passati: all’aumento della produttività del lavoro corrispondeva anche un aumento dei salari degli operai. Sempre più persone, anche quelle di condizione più modesta, potevano permettersi di acquistare ciò che producevano. Questo mise in moto in quasi tutti i Paesi occidentali un potente ascensore sociale. Milioni di persone, per la prima volta nella storia, ebbero accesso liberamente e a costi contenuti, se non addirittura gratuitamente, all’istruzione superiore, alla sanità e al sistema di protezione sociale. E anche ai consumi di massa. Il consumismo, infatti, è un fenomeno nato in quegli anni di boom economico.
E i liberisti cosa c’entrano?
Tra il 1946 e i primi anni Settanta, milioni di persone avevano migliorato la propria condizione economica e sociale e potevano ragionevolmente immaginare che ciò sarebbe avvenuto ancora a lungo. Ci si sbagliava. Non si erano fatti i conti con le risorse naturali, che sono scarse per definizione.
Nel 1974-75 irruppe all’improvviso la crisi petrolifera. Il mondo occidentale conobbe un fenomeno di profonda influenza sulle sorti dell’economia: la brusca carenza di petrolio e il conseguente aumento a livelli stellari dei prezzi dell’energia. Anche la guerra detta dello Yom Kippur, scoppiata nell’autunno del 1973 tra Israele e una coalizione militare di paesi arabi, contribuì a destabilizzare l’economia. Pochi anni prima, il 15 agosto del 1971, il presidente statunitense Richard Nixon aveva dichiarato nullo il legame tra dollaro e oro. La moneta americana era l’unica, grazie agli accordi di Bretton Woods di quasi tre decenni primi, che aveva mantenuto la copertura aurea. Chi possedeva dollari era come se avesse oro in tasca. Dopo questo annuncio, i tassi di cambi tra le varie valute internazionali da semi fissi diventarono flessibili. Un fattore che, unito alla crisi petrolifera, fece da ulteriore detonatore alla forte crisi economica e sociale che caratterizzò il decennio tra il 1970 e il 1980. Inflazione galoppante, disoccupazione e blocco dell’ascensore sociale messo in moto solo pochi anni prima fecero il resto.
Il ‘neoliberismo’ si riaffacciò proprio negli anni Ottanta da una parte all’altra dell’Atlantico interpretato, è il caso di dirlo, negli Stati Uniti dal repubblicano Ronald Reagan, un ex attore hollywoodiano eletto presidente, e dalla premier conservatrice britannica Margaret Thatcher in Europa. Celebre la frase a lei attribuita quando nelle istituzioni comunitarie europee si discuteva della creazione della moneta unica: «I britannici non hanno bisogno dell’euro, hanno già me», affermò. Intendendo con ciò che la disciplina di bilancio pubblico (leggasi arretramento dello Stato) richiesta dalla moneta unica (altro strumento neoliberale, ma questo è un altro discorso, ndr), lei l’aveva già applicata e – dal suo punto di vista – con successo. La sconfitta, in quegli anni, dei sindacati dei minatori inglesi alle prese con un lungo sciopero è emblematica, e allargherà ulteriormente il fossato tra quello che fu il trentennio glorioso e il nuovo mondo in cui ci troviamo.
Il liberismo mentale
In quegli anni slogan come ‘Lo Stato è il problema, non la soluzione’, mutuati dalle campagne elettorali britanniche e nordamericane, fecero capolino anche nel piccolo Ticino. Un modo per sdoganare nell’opinione pubblica del nostro ‘piccolo mondo antico’ le ricette neoliberiste. Meno Stato e più mercato è il mantra ripetuto ancora oggi. Con la caduta del muro di Berlino precedente a quello del blocco sovietico il ‘realismo liberista’, per parafrasare Mark Fisher, è diventato l’unico mondo possibile.
Il nostro agire quotidiano è circoscritto in una matrice ideologica inconsapevole. I tentativi di limitare la concorrenza sono interpretati come azioni ostili alla libertà (guai a chi tocca i giganti di internet, per esempio). La pressione fiscale e la regolamentazione del settore pubblico, nell’accezione comune, ormai dovrebbero tendere al minimo (sgravi fiscali, ndr). I servizi pubblici dovrebbero essere se non privatizzati, gestiti secondo criteri aziendalistici. L’organizzazione del lavoro e la contrattazione collettiva sono considerate – non solo dalle imprese – come distorsioni del mercato (si vedano gli strali contro il salario minimo). La disuguaglianza è ridefinita come virtuosa: un premio per i migliori e un generatore di ricchezza che viene redistribuita verso il basso per arricchire tutti. Gli sforzi per creare una società più equa sono considerati controproducenti. «Il mercato fa sì che ognuno ottenga ciò che merita»: quante volte si sentono ragionamenti simili, anche dal collega di scrivania o in pausa caffè?
Noi interiorizziamo e diffondiamo questo credo. I ricchi si autoconvincono di aver acquisito la loro ricchezza attraverso il merito, ignorando i vantaggi (come l’istruzione, l’eredità e la classe sociale d’appartenenza) che possono averli aiutati ad assicurarsela. I poveri cominciano a incolpare sé stessi per i propri fallimenti, anche quando possono fare poco per cambiare la situazione.