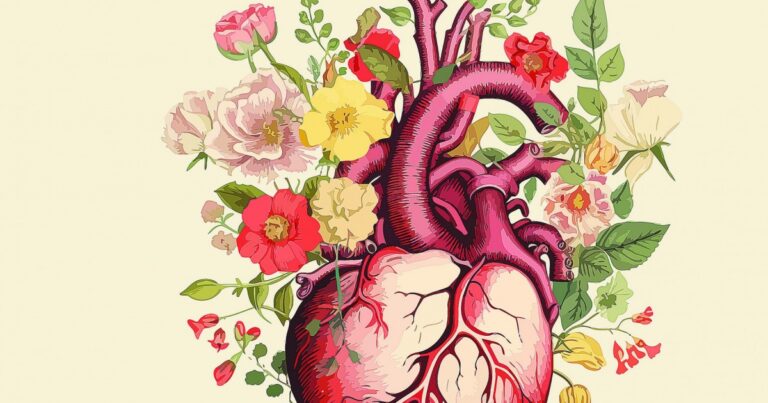Sicilia ferita. Il mare che s’è mangiato la costa

A circa due settimane dal ciclone Harry, come un messaggio in bottiglia riportiamo le parole di chi è tornato a casa per vedere con in propri occhi
Di Marco Narzisi
All’incirca due settimane fa, il ciclone Harry si è abbattuto sulle coste di Sardegna, Calabria e Sicilia, lasciando dietro di sé devastazione e sconforto. Come un messaggio in bottiglia proponiamo le parole di chi è tornato a casa, sull’isola di Trinacria, per riabbracciare la propria famiglia e vedere con i propri occhi ciò che è rimasto e, soprattutto, la forza di una terra che deve rimettersi in piedi.
“Nera che bussa forte, che butta giù le porte”. Mi risuonano in testa le parole di Fabrizio De André in Dolcenera, memoria dell’alluvione di Genova del 1970, mentre cammino sul lungomare della “mia” Roccalumera, il paesello in cui sono cresciuto in quella riviera ionica messinese travolta dal ciclone Harry. Perché era nera di sabbia l’onda che ha bussato forte a casa dei miei genitori: non ha buttato giù le porte, si è limitata, bontà sua, a spalancare i cancelli, compreso quello enorme del garage.

© M.N.
Tabula rasa
I segni della mareggiata di poco più di due settimane fa sono ancora là, nei tratti di lungomare transennati, come cerotti qua e là su ferite aperte dove il mare ha graffiato e portato via pezzi di muretto, marciapiede, asfalto. E nella sabbia, che non è quella fine delle spiagge adriatiche ma corposa, densa di pietre e spessa ghiaia, che in spiaggia non ti resta attaccata come farina su una cotoletta, ma ti preme e punge i piedi e che ora è ovunque, nelle aiuole, nelle viuzze che portano al mare, nei cortili delle case. Certo, si torna alla normalità, pian piano: bar, ristoranti e negozi hanno asciugato l’acqua, rimesso in sesto le saracinesche e riaperto, le ruspe portano ancora via i detriti, si spala via la sabbia da vialetti e giardinetti.

© M.N.
Ma restano i danni, tanti e dolorosi: il mare ha fatto tabula rasa delle terrazze del chiosco e della focacceria, mentre del lido dove era piacevole bere un drink fino a tarda sera, semplicemente non resta più nulla, se non una montagna di sabbia e palme divelte su cui gli operai lavorano per salvare il (poco) salvabile. Qui e là, nel muretto mangiato via, si aprono delle specie di finestre a strapiombo sulla sabbia: c’erano le scalette per scendere in spiaggia, finite ora chissà dove. Più in là, nella confinante Nizza di Sicilia, le attrezzature sportive del percorso vita fronte mare giacciono sbattute qua e là, accanto alle panchine che emergono come scogli da un mare di sabbia, agli alberi spezzati: una palma resiste ancora, piegata verso la spiaggia, ancora attaccata con tutte le sue forze a ciò che rimane delle radici. Il sindaco è in giro, lo incontro per caso, mi dice che tutto sommato procede bene. “Il peggio è a Santa Teresa”, aggiunge, “bisogna andare a piedi per capire cos’è successo”.

© M.N.
Una comunità ferita
Ci sono andato, a Santa Teresa di Riva, e constato che, purtroppo, ha ragione: se a Roccalumera il mare ha graffiato, qui le onde hanno azzannato, sbranato, dilaniato. Decine di metri di lungomare letteralmente strappati, l’asfalto strappato via come una pellicina fastidiosa fino a mostrare al di sotto tubi idrici e cavi elettrici tranciati, gli alberi che ornavano il marciapiede sprofondati con le cime che sporgono a livello della strada come ciuffi di erbacce in un’aiuola. Qui e là si aprono squarci larghi diversi metri, dove prima esistevano un muretto, una piazzetta: come quella in cui si trovava, su un piedistallo, la scultura metallica Galassiopea, che ora giace sdraiata, supina sulla spiaggia come una copia a buon mercato della Statua della Libertà ne Il pianeta delle scimmie. Più avanti, il lungomare semplicemente non esiste più: al suo posto una voragine, un taglio largo e netto nella carne viva del paese diviso in due. E non è andata meglio poco più in là, a Furci Siculo: anche qui il bel lungomare è un ricordo travolto da sabbia e macerie.

© M.N.
Hanno detto in tanti, troppi: “È una mareggiata come tante, ci sono sempre state”, come a dire che forse ci stiamo lamentando troppo, che in fondo non è successo nulla e, fra le righe, che forse un po’ ce lo meritiamo, ad aver voluto costruire un bel lungomare vivibile anziché lasciare lo sterrato che era là fino ad alcuni decenni fa. Lo dicono senza aver mai messo piede da quelle parti, senza aver mai visto le mareggiate che, è vero, a volte creavano danni, ma il più delle volte lasciavano al massimo un po’ di sabbia e detriti per le strade. Perché forse, in fondo, fa comodo dire che “è sempre accaduto”, minimizzare serve, sicuramente, a evitare di dover dire quelle due parole, “cambiamento climatico”, che per tanti suonano fastidiose, moleste fino alla necessità di sminuire. O negare.

© M.N.
Una facile generalizzazione
E poi c’è chi, troppo spesso a sproposito, ripete il mantra ricorrente ogni volta che si parla di una qualsiasi calamità naturale da Roma in giù: abusivismo. Una sorta di safe word per togliersi dall’impiccio di dover mostrare una qualsiasi forma di solidarietà incondizionata e al tempo stesso l’ennesima manifestazione dell’epidemia che da tempo affligge i social: quella delle lezioni calate dall’alto, della generalizzazione facile, della colpevolizzazione delle vittime. E in effetti sembra che non sia successo nulla: almeno a giudicare da quanto tempo ci hanno messo gli esponenti politici, da una parte e dall’altra, a farsi vedere da quelle parti, o dal rilievo dato, almeno inizialmente, alla notizia sui principali media italiani, fra un discorso strampalato di Trump e qualche altra questione internazionale: sarà che non è morto nessuno?
E intanto si va avanti, si ricostruiranno i lungomari, si riapriranno negozi e locali, si tornerà alla normalità: resta però, in tanti, l’incertezza che possa succedere ancora, che quel mare visto finora come un amico, a tratti solo un po’ più fastidioso, mostri ancora il suo volto peggiore, torni a ferire, a colpire di notte come un ladro. Ma lo ha detto il “mio” sindaco, salutandomi prima di andare via: “Ce la dobbiamo fare”. Non possiamo, dobbiamo.