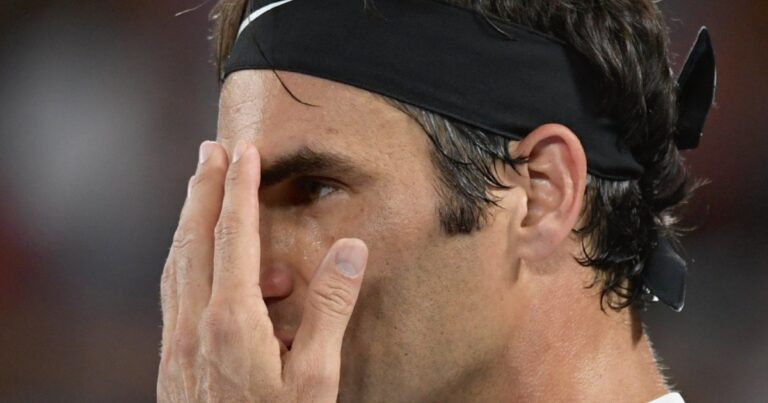Lalla Romano, qualche nota circostanziata di silenzio

La scrittrice piemontese: ‘L’attenzione acuta fino alla sofferenza e insieme rapida, asciutta, una sorta di concentrazione disperata…”
Di Marco Stracquadaini
Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione
La poetessa, scrittrice, giornalista e aforista piemontese è nata l’11 novembre 1906 ed è morta il 26 giugno 2001, a 94 anni. Nell’intercorrere fra le date estreme, Romano è stata incoraggiata da un giudizio positivo di Eugenio Montale che l’ha spronata a pubblicare alcune sue poesie: la raccolta d’esordio è ‘Fiore’. Il suo carattere severo, rigoroso, introverso e portato a scavare nell’intimo è stato la cifra specifica del suo percorso letterario. L’opera che l’ha fatta emergere e conoscere al grande pubblico è ‘Le parole tra noi leggere’ che ha vinto il Premio Strega nel 1969.
“Mi è sembrato giusto chiamare presente il passato, perché quando lo rievochiamo ha già la nostra impronta e non è più del tutto estraneo. Non ci assale, ma risponde”. Così Lalla Romano spiega il titolo scelto per il libro intervista L’eterno presente (Einaudi, 1997), a cura di Antonio Ria. Tra i critici che si sono occupati de La penombra che abbiamo attraversato alla sua prima uscita, nel 1964, Carlo Bo notava che dove si parla dei genitori la voce prende una pronuncia speciale. Come qui per esempio, dove l’evocatività dei nomi non è certo casuale: “Scendevamo oltre il Cant, seguivamo i muri secchi verso il Cornalé. Il paese e la campagna, tutto era bianco e nero. C’era un grande silenzio. Volavano i corvi, come nelle fiabe dei Grimm. Scavando sotto la neve, tra i ghiaccioli, si trovava il muschio umido e verde (…). Papà lo staccava piano, perché le toppe non si frantumassero. Le mani di papà erano delicate, erano impacciate, quando aiutava noi bambine a vestirci, e non riusciva a infilare i bottoni nelle asole (…). Le mani di papà erano asciutte, calde, e la mia vi scompariva; mi sembrava di entrarvi tutta intera, come in un nido”.
Tutto parte dalla poesia
Lalla Romano ha cominciato con la poesia – con versi di questo calibro riconosciuti all’istante da Gianfranco Contini: “Io sono in te/ come il caro odore del corpo/ come l’umore dell’occhio/ e la dolce saliva” – e passando alla prosa non se n’è mai distaccata. Tre raccolte di versi (Fiore del 1941, L’autunno del ’55, Giovane è il tempo del ’74), una di sogni, Le Metamorfosi (1951), e nove libri che a stento si chiamerebbero romanzi, tutti di tema “famigliare”. Ogni scrittrice, ogni scrittore crea generi a sé. Un genere per libro addirittura, nel migliore dei casi. Scrisse inoltre un Diario di Grecia, tre libri di letture di immagini fotografiche (tanto per ribadire il genere a sé) e negli ultimi anni i testi frammentari de Le lune di Hvar, tra il diario di viaggio e la raccolta di note e di aforismi, come un distillato della scrittura più estesa precedente, che era già ugualmente essenziale. Nel suo passato, nell’infanzia de La penombra che abbiamo attraversato o nella giovinezza di Una giovinezza inventata (1979), nella vita famigliare in Maria (1953) – che è anche un intenso ritratto femminile – per citare solo tre titoli, la scrittrice non ricerca fatti, perché “i fatti di per sé non sono nulla”, nemmeno nobilitati in eventi, ma la segretezza dei gesti, delle parole, delle immagini (a testimoniare la segretezza delle relazioni): quella parte perduta che solo ora, a tanta distanza, si può scorgere. Solo chi viva nel silenzio intimo e nella lontananza costanti, qualsiasi cosa le stia succedendo intorno, può fare questo. “Per me scrivere è stato sempre cogliere, dal tessuto fitto e complesso della vita qualche immagine, dal rumore del mondo qualche nota, e circondarle di silenzio”. Allora i gesti e le scene rievocati nascono sulla pagina senza perdere quello stesso silenzio e quella lontananza, che possono diventare anche di chi legge.
Tutto sa di diario
Tutti i libri di Lalla Romano sanno di diario, se si toglie al genere ogni traccia di provvisorietà e casualità, di nota fissata nel più breve tempo con l’intenzione di precisarla. Due libri lo sono espressamente – il nominato Diario di Grecia (1959 e, in edizione più estesa, 1974), Le lune di Hvar (1991) resoconto di quattro viaggi in Croazia – e un altro in maniera più indiretta: Nei mari estremi (1987) “cronaca” della morte del marito e retrospettivamente della vita passata insieme (la parte sulla vita, scritta dopo, è stata collocata in apertura).
La scrittura diaristica ci aiuta a comprendere la qualità rara della memoria che compare negli altri libri. Lì si vede come lavora sul presente, sulla vita quotidiana. Uno sguardo che è appunto un lavorio tanto penetrante da arrivare alle soglie della visione. Niente è trasformato, ma tutto diventa nitido e tremolante, segreto e già evocativo. Si comprende allora perché, rievocando il passato, la scrittura riveli quasi soltanto questo nucleo di mistero. Come se la rievocazione fosse cominciata allora, al primo sguardo.
Questo che segue è l’incipit di Maria, la domestica che resterà tanti anni nella casa. “Quando entrammo nella nostra casa c’era già Maria. Eravamo di ritorno dal viaggio, e camminammo in punta di piedi, perché era mezzanotte (…). Affrontare la conoscenza delle persone mi metteva in grande imbarazzo, così, da una stanza vicina, avevo spiato, attraverso l’uscio socchiuso”.
Scrittura padroneggiata
Vi si intuiscono altre caratteristiche della maniera di guardare di Lalla Romano: arrivare in profondità attraverso il tatto, la lentezza e la circospezione. Le immagini risalgono dal passato trovando la strada da sé: la scrittura non fa altro che riceverne il calco frenandone l’urgenza. E manca qui la parte cruda e tagliente di tale sguardo. Un altro aspetto appare nei due brani più ampi riportati: semplicemente pensando alla funzione dei punti fermi, delle virgole, nella scrittura così padroneggiata, di tanto in tanto leggendo balenano la parola e il concetto di “stile”, piuttosto screditati oggi l’uno e l’altra, o eclissati, e un senso di incongruenza te li fa ricacciare indietro.
La parola però non è ancora sparita che già pronuncia una serie di nomi, restando alla scrittura femminile: Morante, Campo, Ginzburg, Banti, Manzini… I classici del Novecento ora più che classici e che, salvo Natalia Ginzburg e compresa Lalla Romano, disertano le librerie da due o tre decenni. Rade presenze che sono un vero disertare.
Che cosa sia lo stile naturalmente non si sa. Quel che si sa è che, se c’è, si vede. Se non si vede, vuol dire che non c’è. E se non c’è, spariscono scrittura e scrivente. La digressione, trattandosi di Lalla Romano, forse non è una digressione, tanto il concetto le è connaturato.
Le parole per sé stessi
Tento ancora una o due approssimazioni: la prima con un giudizio di Cesare Segre, curatore dei Meridiani Mondadori dedicati alla scrittrice: “La narrazione si rivela come un’amorosa investigazione”, la seconda con le parole della stessa Romano, ancora una volta su quello sguardo da cui comincia tutta la sua arte: “L’attenzione acuta fino alla sofferenza e insieme rapida, asciutta, una sorta di concentrazione disperata…”. Quando La penombra che abbiamo attraversato fu tradotto in francese, nel 1992, fu recensito dal poeta Alain Bosquet, che parlò del potere illimitato delle parole di far rivivere ciò che è morto; della familiarità dei ricordi, ma anche della loro fragilità e fuggevolezza; della irrealtà delle immagini, che le rende universali, e ognuno vi si può accostare come alle proprie.
Nelle pagine di quel libro come in tante altre di Lalla Romano – cito almeno altri tre titoli: Le parole tra noi leggere (1969), dedicato al figlio e uno dei suoi libri più letti, L’ospite (1973) e Inseparabile (1981) in cui protagonista è il nipote bambino – in certi momenti le parole hanno la naturalezza e la gratuità delle cose raccontate a sé stessi, quando non vogliamo colpire o impressionare nessuno.